di Sergio ROSSI
CRONACHE VENEZIANE
Massimo Campigli e gli Etruschi Una pagana felicità. ACP – Palazzo Franchetti, Venezia, 23 maggio – 30 settembre 2021 ( San Marco 2842 – 30124 Venezia Telefono: +39 041 2689389 http://www.acp-palazzofranchetti.com )
In un mio recente soggiorno a Venezia ho potuto constatare con piacere che la città lagunare si sta nuovamente e progressivamente riempiendo di turisti (ma senza quelle resse oscene pre-covid) e che la sua offerta espositiva, anche con questo caldo agostano, non ha confronti con quella delle altre città italiane. E questo grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e private ed alla apertura al contemporaneo di spazi storici di grande fascino e bellezza.
 Inizierò il mio excursus da Campigli e gli Etruschi. Una pagana felicità, a cura di Franco Calarota (Palazzo Franchetti, fino al 30 settembre): una bella mostra, come un bel libro o un bel film, deve sviluppare in modo coerente ed efficace, senza lacune o ridondanze, l’idea originale intorno alla quale si snoda la trama. E questo accade perfettamente nella nostra esposizione. Certo il rapporto tra Campigli e gli Etruschi non lo si scopre a Palazzo Franchetti, ma mai era stato reso così esplicito e convincente, grazie anche all’ottima sinergia che si è instaurata tra la Art Capital Partners per la parte contemporanea e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale per quel che riguarda i reperti antichi.
Inizierò il mio excursus da Campigli e gli Etruschi. Una pagana felicità, a cura di Franco Calarota (Palazzo Franchetti, fino al 30 settembre): una bella mostra, come un bel libro o un bel film, deve sviluppare in modo coerente ed efficace, senza lacune o ridondanze, l’idea originale intorno alla quale si snoda la trama. E questo accade perfettamente nella nostra esposizione. Certo il rapporto tra Campigli e gli Etruschi non lo si scopre a Palazzo Franchetti, ma mai era stato reso così esplicito e convincente, grazie anche all’ottima sinergia che si è instaurata tra la Art Capital Partners per la parte contemporanea e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale per quel che riguarda i reperti antichi.

Lo stesso Campigli, tra i più lucidi e loquaci artisti del Novecento nella narrazione della propria opera, sembra anticipare, in più di un’occasione, il tema centrale della mostra:
«L’influenza che subii più a lungo fu quella dell’arte etrusca che nel 1928 diede una svolta alla mia pittura. S’intende che conoscevo come ogni altro l’arte etrusca. Ma al Museo Archeologico di Firenze tutta la mia attenzione era andata, sino allora, agli egizi e per un’arte che non fosse precisa e geometrica non avevo occhi. Solo nel 1928 in una visita a Roma nel Museo di Villa Giulia mi trovai pronto a ricevere in pieno il coup de foudre. Tal quale come si può incontrare ripetutamente una donna che siamo destinati ad amare, e risentire il coup de foudre solo nel momento che era ‘scritto’, come dicono i musulmani. E allora si esclama:
‘Mi pare di averla sempre amata’. Mi riconobbi negli etruschi. Con l’aiuto di un po’ di poesia si è subito portati in simili casi a dirsi: ‘questa vita l’ho già vissuta’ e a immedesimarsi anche un po’ troppo […] Comunque comincia da quell’incontro con gli etruschi la mia pittura tipica, mentre sconfesso quella di prima del 1928 che mi pare di una qualità pietosamente scadente […] Amai questa umanità piccola sorridente e che fa sorridere. Trovai invidiabile il sonno beato sui sarcofaghi di queste altre odalische di terracotta e il loro modo di essere morte. Nei miei quadri entrò una pagana felicità, tanto nello spirito dei soggetti che nello spirito del lavoro che si fece più libero e lirico: non propongo a nessuno di ispirarsi agli etruschi. È un mio caso personale, una debolezza insomma. Per anni ho scacciato gli etruschi dalla mia porta: rientrano dalla finestra».
Ed è proprio la morte “sorridente e radiosa” (vista dalla cella dell’ospedale psichiatrico in cui era rinchiuso), come ebbe a descriverla van Gogh in una memorabile lettera al fratello Theo, identificata con la luce ed il sole e non con le tenebre, un sole però che non proietta ombre, che ritroviamo, depurata da ogni sostrato psicotico ed autodistruttivo, insieme ad una “pagana felicità”, nella pittura di Campigli, che certo a prima vista da van Gogh non potrebbe essere più distante ma che pure in questo viaggio alla Camus dalle tenebre alla luce con il grande olandese qualche segreta affinità la presenta:
«Forse perché fu lungamente presentita e attesa […] nel messaggio che lessi nell’arte di Roma ha gran parte, oltre all’emozione artistica, e magari più dell’emozione artistica, la “consolazione” che mi offrono le rappresentazioni della morte nell’arte antichissima che è, del resto, sempre funeraria. Io ho verso la morte un sentimento pacato e amichevole che si accorda perfettamente con l’amore della vita, con l’approvazione della vita. Certe cose mi fanno pensare alla morte quasi con nostalgia, come gli alberi altissimi e lo sciacquio del mare, le montagne rocciose, gli oggetti antichissimi e le città morte (dunque i musei in genere). I musei fanno vibrare in me l’arcaico, il nostalgico di tempi remoti. La preistoria mi consola dalla morte […] a Villa Giulia, poi anche alle Terme di Diocleziano, i miei rapporti con la morte mi divennero più chiari […] Ed ecco le urne etrusche, e una rivelazione: che queste grosse teste, non importa che somiglino al defunto, sono l’equivalente, la somiglianza è segreta, come la vita dell’effige è segreta. Gli egiziani sentivano la stessa cosa ma non me lo avevano comunicato. La sopravvivenza dell’immagine etrusca invece posso sentirla. Non essere, ma vedere il sole attraverso occhi di terracotta! le tombe nostre dovrebbero avere occhi dipinti come le navi antiche e i bragozzi dell’Adriatico ancor oggi. È chiaro che ho della morte un sentimento magico, per così dire, e plastico. Vita diventata forma. Maestà dell’immobilità. Indifferenza del morto: indifferenza della perfezione».

Certo, a posteriori, lo stesso Campigli esagera forse l’impatto che la “svolta etrusca” ha avuto sulla sua pittura, che è la logica conseguenza e non la cesura definitiva delle sue esperienze precedenti, come dimostrano Les Tziganes del 1928, che molto opportunamente Martina Corgnati, nel bel Catalogo che accompagna l’esposizione, definisce punto d’arrivo di tutto il lavoro precedente e, al tempo stesso, atto di nascita di quello successivo:
«La struttura del quadro basata sulle ortogonali era quella consueta e già abbondantemente sperimentata: l’impaginazione è data da un’ordinata sequenza di linee verticali e orizzontali attraversate dalla diagonale dell’acquedotto che si perde in lontananza, lungo un asse prospettico contraddetto dalla sostanziale mancanza di orizzonte. La figura sdraiata in primo piano, assorta nel suo solitario, tiene gli occhi bassi, e presenta un volto inespressivo e convenzionale, non troppo diverso da quello di numerose altre figure femminili dipinte negli anni venti. Anche la superficie pittorica, inaridita e gessosa se non addirittura desertica, porta alle estreme conseguenze il trend già evidente nei dipinti presentati alla Biennale. Ma l’atmosfera è completamente cambiata: l’aura metafisica si congiunge con una sensualità nuova e intensa, veicolata soprattutto dall’ermetico ma desiderabile personaggio in primo piano, dalla lunga gonna scura e le chiome divise dalla scriminatura centrale che lascia intuire due lunghe trecce e prosegue idealmente nella linea elegante della colonna vertebrale. La vita, strettissima, trasforma il dorso della ragazza in una specie di delicata clessidra, completata dall’anfora bruna che ella trattiene appoggiandola all’anca. Un arcaico chiarore mediterraneo emanato da un sole senza raggi irrora l’insieme».
Il particolare fascino di questo dipinto è acuito in mostra dal confronto col bellissimo Sarcofago femminile ora al Museo civico archeologico di Viterbo, che presenta lo stesso color ocra intenso delle “zingare” campigliane del nostro dipinto, la stessa atmosfera sospesa e fluttuante, carica di mistero;
eppure qui l’artista non si è ancora liberato del tutto da certe reminiscenze parigine, le carte da gioco, la figura maschile a cavallo, un’aura cubista che ancora permane, mentre il sole pallido che riceve la luce più che trasmetterla ci introduce già verso orizzonti del tutto nuovi che troviamo poi perfettamente compiuti nel delizioso Bambine del ’32, esercizio pittorico di un lirismo assoluto, assimilabile all’ungarettiano “m’illumino d’immenso”, anche se la palla in primo piano, quasi un sole rovesciato e le figure fantasmatiche delle bambine senza volto ci ricordano come il mistero della vita e della morte sia sempre in agguato.

Le immagini femminili si rassodano e diventano quasi un blocco unico ne La spiaggia del ’37, mentre poi il tema dello sdoppiamento prende il sopravvento in una serie di figure gemelle che raggiungono il loro vertice qualitativo nel concerto a quattro mani delle Pianiste di dieci anni dopo, preceduto di poco dal perfetto ovale di Giuditta, dove ormai l’arte romana ha soppiantato quella etrusca. Ma come diceva Maurizio Calvesi, nelle recensioni delle mostre, come dei libri, la tentazione da evitare assolutamente è quella di cavarsela facendone il riassunto, per cui a questo punto non mi rimane che invitare i lettori a visitare la mostra che merita assolutamente di essere vista, non prima però di avere osservato come tutta la pittura di Campigli, almeno quella più riuscita, è una pittura fatta per “sottrazione”, un po’ come, fatte le debite differenze, quella di Giorgio Morandi o Mark Rotko, per cui ho accolto con grande interesse l’annuncio di Franco Camerota di una
«grande mostra che, in concomitanza con La Biennale di Venezia del 2022, vedrà esposti insieme due giganti dell’arte del secolo scorso, mai esposti prima insieme in un dialogo così approfondito e diretto: Giorgio Morandi e Mark Rothko».
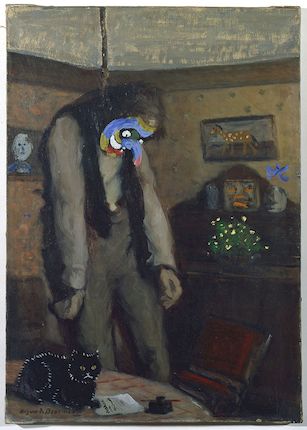
A questo punto il passaggio da Palazzo Franchetti a Ca’ Corner della Regina, sede della Fondazione Prada e della mostra Stop Painting, ideata e curata da Peter Fischli, non potrebbe essere più spiazzante ed insieme stimolante: da un luogo tutto equilibrio, armonia, trionfo della pittura si passa infatti ad un luogo volutamente disarmonico, schizofrenico, urlato, caleidoscopico ma egualmente affascinante, dove si celebra la morte della pittura ed insieme la sua immortalità. «Perché smettere di dipingere? Meglio smettere di smettere di dipingere -osserva infatti lo stesso Fischli- Eppure, l’eco distorta della domanda “perché dipingere?” non è svanita del tutto dal discorso estetico. Presentandosi come una versione aggiornata di Frankenstein, agile e vivace -un Frankenstein reduce da un intervento di chirurgia estetica perfettamente riuscito- la pittura circola in un costante processo di “morphing” in una infinita quantità di dispositivi…Invece di obbedire a modalità di distribuzione consolidate e obsolete, le immagini viaggiano a un nuovo livello di velocità. La circolazione continua ha soppiantato la distribuzione. I contesti e le narrazioni cambiano a ritmi iperveloci e nel frattempo si accumula valore: valore economico e simbolico».
Se, come ho appena scritto, recensire una mostra facendone il riassunto è comunque da evitare nel caso di Stop Painting sarebbe assolutamente impossibile e fuori luogo: bisogna solo vederla, immergersi nella sua apparente illogicità, lasciarsi trasportare dal flusso delle immagini e poi magari provare a ripensarla a mente fredda, come una sorta di vademecum dell’arte degli ultimi cinquant’anni e passa, da Asger Jorn, a Michelangelo Pistoletto, da Carla Accardi a Lucio Fontana, da Francis Picabia a Marcel Breuer, eccetera eccetera …
Quello che a questo punto mi preme l’obbligo di fare è piuttosto dire la mia sul perché l’arte in generale e la pittura in particolare non solo non sono morte ma anzi godono di ottima salute, come le due mostre di Georg Baselitz di cui mi occuperò tra breve, dimostrano in modo ineccepibile. Ed il motivo di fondo è che l’arte d’avanguardia del nostro immediato dopoguerra, in particolare nelle versioni dell’arte povera e di quella concettuale era indissolubilmente legata all’idea di una società postmoderna e cioè post, e di conseguenza anti, storica, cui io mi oppongo radicalmente. Infatti, dal momento che non si può negare o contestare ciò che non esiste, anche le più radicali negazioni o contestazioni del proprio passato e della propria storia non possono prescindere da quest’ultima. Ne consegue che la cosiddetta società postmoderna è essa stessa l’anello (e ormai non l’ultimo) di quella catena culturale che ha permeato, permea e permeerà la nostra stessa esistenza.
Dunque, i “Pali” di Kounellis, le “Finestre” di Tano Festa, gli “Igloo” di Merz, gli “Stracci” di Pistoletto, per restare in ambito italiano, e prima di loro i “Tagli” di Fontana e financo le “Merde” di Manzoni non sono gesti isolati di naufraghi comparsi all’improvviso su di un’isola misteriosa, come i sopravvissuti della serie televisiva di Lost, ma piuttosto parte di quella storia che si è formata prima di loro e dopo di loro continuerà e che noi abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare nel migliore dei modi possibili, perché, come sosteneva il filosofo polacco A. Nowicki, la cultura (e io aggiungo l’arte) siamo noi, del passato, del presente e del futuro.
Che poi la pittura sia come non mai viva e vegeta, lo ripeto, è dimostrato in modo inconfutabile dalle due mostre che Venezia dedica a Georg Baselitz, quella di Palazzo Grimani e quella della Fondazione Vedova. Le ho visitate a due anni di distanza da quella della Galleria dell’Accademia ed a nove dall’altra su Baselitz sculpteur del Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Ed alcune delle considerazioni che facevo allora trovano assolutamente conferma dopo questo lungo lasso di tempo, a partire da quella relativa al rapporto fondamentale tra l’artista tedesco e Michelangelo.

Certo, a prima vista, non può esservi nulla di più lontano della furia quasi barbarica di Baselitz dalle sculture del Buonarroti; solo a prima vista però, perché, ad esempio una statua come Die Mädchen von Olmo II non sarebbe mai potuta esistere senza i Prigioni e se questa mia può apparire una provocazione, non credo debba dispiacere a un “provocatore” per antonomasia, naturalmente nel senso migliore del termine, quale appunto Baselitz è.
Innanzitutto i dipinti e le statue di Baselitz non sono fatti per essere contemplati singolarmente, ma vanno ammirati nel loro complesso (e del resto lo stesso vale per i Prigioni michelangioleschi), come il dipanarsi di un discorso, o se si vuole un racconto, insieme autobiografico ed universale, tedesco nella sua essenza (si pensi alla bellissima serie delle Donne di Dresda) e nel contempo pieno di riferimenti all’arte africana o addirittura dell’isola di Pasqua da un lato ma anche alla semplificazione formale del costruttivismo russo dall’altro. Naturalmente non sono “belle”, perché “il diritto al brutto” è stata una delle principali conquiste estetiche di Baselitz e dei “Nuovi selvaggi”, ma nemmeno i più astratti dei Prigioni o la stessa Pietà Rondanini sono belli nel senso classico del termine, anzi forse sono la prima compiuta espressione del “brutismo” nell’arte occidentale. Del resto alla domanda di quale consiglio Baselitz darebbe a un giovane artista egli ha provocatoriamente risposto: «E’ facile dipingere dei buoni quadri. Farne di cattivi è ben più difficile. Pertanto ci si dovrebbe sforzare di fare delle cattive opere perché sono quelle le buone. Io voglio dire che bisogna diffidare di ciò che si ama e di ciò che si conosce».
Ma anche Michelangelo, dopo aver dichiarato nel 1541
“Per fido esemplo alla mia vocazione/ nel parto mi fu data la bellezza, /che d’ambo l’arti m’è lucerna e specchio” una decina di anni più tardi affermava che “l’affettüosa fantasia/Che l’arte mi fece idol e monarca/Conosco or ben com’era d’error carca”.

Da “lucerna e specchio” la bellezza e l’arte diventano addirittura una minaccia, qualcosa di cui liberarsi per aspirare alla salvezza divina. In realtà, questa rinuncia all’arte Michelangelo non riuscirà mai a compierla, come confermano due statue, di cronologia controversa ma comunque estrema, ossia la Pietà di Palestrina e la Pietà Rondanini, puri lacerti spirituali di una bellezza tanto più meravigliosa e assoluta quanto più assente. Ecco sembra proprio che Michelangelo abbia con cinque secoli di anticipo dato ascolto a Baselitz, rinunciando proprio a ciò che conosceva ed amava per raggiungere la vera essenza spirituale delle cose. E lo stesso artista tedesco ha affermato che ciò che più lo interessa degli artisti del passato sono le loro opere tarde.
In definitiva, sostenere che esista un filo sotterraneo e segreto che al di là di ogni apparenza leghi Baselitz e Michelangelo mi pare assolutamente corretto. Non a caso, del resto, il giovane Georg si è formato a Firenze studiando i due più grandi eredi spirituali del Buonarroti, cioè Pontormo e Rosso Fiorentino. E se vogliamo continuare nel paradosso, allora va detto che anche quello che è diventato una sorta di segno di riconoscimento della pittura di Baselitz, cioè il capovolgere tutte le sue figure, trova anch’esso nei Dannati del michelangiolesco Giudizio Universale una sua anticipazione.

E proprio questo “rovesciamento”, che già al suo esordio aveva costituito una sublime ed esplosiva provocazione, si è poi andato via via affinando nel tempo fino a raggiugere nei capolavori di questi ultimi anni delle vette assolute di arte pura, in cui l’elemento trasgressivo e quello poetico si saldano alla perfezione, in quella che può definirsi come una sintesi di tutta l’arte dell’ultimo mezzo secolo, dove Baselitz si muove come un equilibrista sempre in bilico tra figurazione e astrazione, segno e materia, novità e tradizione.
Tutte caratteristiche che ritroviamo nelle due mostre attualmente aperte a Venezia. Inizierò da Archinto, dodici tele realizzate appositamente per la Sala del Portego di Palazzo Grimani e collocate nelle originarie cornici settecentesche a stucco; l’esibizione, prodotta dalla Gagosian Galery in collaborazione con Venetian Heritage sarà aperta al pubblico fino al 27 novembre e grazie a uno speciale accordo, queste opere rimarranno in comodato a lungo termine al museo per concessione dell’autore. Ed è la prima volta che avviene una simile collaborazione tra un artista contemporaneo e un museo statale veneziano.
Il titolo della mostra e i suoi lavori, come è noto, fanno riferimento al ritratto del Cardinale Filippo Archinto che Tiziano realizzò nel 1558, ora conservato preso il Philadelphia Museum of art. La pennellata sfrangiata e trasparente del Vecellio trova qui uno dei suoi esiti più enigmatici e virtuosistici, quasi preludio al Velazquez del Ritratto di Innocenzo X della Galleria Doria Pamphilj, e rivive ora con Baselitz a Palazzo Grimani in una sorta di duetto coinvolgente ed entusiasmante.
Il fatto che Baselitz sia tornato ora a Venezia ed abbia voluto instaurare con la città un dialogo insieme esplicito e segreto non è comunque per niente casuale: innanzi tutto perché la città stessa, nata dalle acque e che di acqua vive, è la sede ideale per la pittura “liquida” ma insieme materica e gestuale del grande artista tedesco, e poi perché sono stati proprio Tiziano e Tintoretto (si pensi al suo immenso capolavoro della gigantesca Crocifissione della Scuola di San Rocco che ogni volta che vengo in questa città non finisce mai di sedurmi), sono stati proprio questi due artisti, se vogliamo, ad anticipare di quattro secoli la pittura gestuale, appunto, in cui il colore prevale decisamente sul disegno. Ma a Palazzo Grimani ritroviamo anche un tema che avevamo lasciato a Palazzo Franchetti, con Campigli, quello della morte, là appena accennato come una marcia funebre in sottofondo, qui urlato e spettrale ma egualmente depurato da ogni accento pessimistico, come se un attore lanciasse in aria un teschio per poi riprenderlo al volo prima di intonare il celebre monologo dell’Amleto.
Quasi a fare da pendant a questo omaggio ad un grande veneziano del passato ecco l’altra mostra, Vedova accendi la luce, aperta fino al 31 ottobre ai Magazzini del Sale, in cui Baselitz dialoga col più grande pittore veneziano del nostro tempo, Emilio Vedova, appunto, di cui è stato amico ed in qualche misura discepolo, nella Berlino degli anni Sessanta. Si tratta di diciassette grandi tele, anche queste dipinte per l’occasione e che possono dividersi in due gruppi: sette sono “ritratti” rovesciati dell’amico scomparso e dieci fanno parte della serie del “gelato” (Speiseis) e sono dedicati alla moglie Elke, quasi a formare un flusso continuo ed ininterrotto che propaga la sua contagiosa energia e che meglio di qualunque dissertazione filosofica dimostra coi fatti e non con le parole che la pittura non è morta e che fin quando esisteranno artisti come Baselitz che sanno usare insieme la mente e la mano, non potrà morire.
Sergio ROSSI Roma 5 settembre 2021




