di Nicola SPINOSA
In questa settimana prima di ferragosto About Art online presenterà una serie di saggi relativi al dibattutissimo tema del metodo di lavoro di Caravaggio, ospitando saggi già apparsi in stampa e rielaborati o del tutto inediti, da parte di alcuni fra i più importanti studiosi dell’opera del genio lombardo che hanno cortesmente aderito a questa iniziativa. Cominciamo con un importante intervento di Nicola Spinosa che ringraziamo insieme al Direttore della Pinacoteca di Brera James M. Bradburne e all’editore Skira. Il prossimo contributo sarà di Rossella Vodret
Attorno a Caravaggio 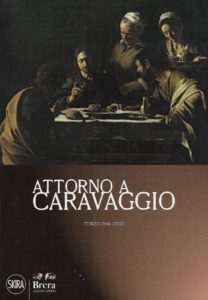
Com’è ampiamente noto, Caravaggio, dopo aver ucciso in uno scontro il 28 maggio 1606 Ranuccio Tomassoni, si era rifugiato ferito nel palazzo Colonna a Paliano e poi a Palestrina, sotto la protezione della marchesa Costanza Colonna Sforza. Prima di trasferirsi a Napoli, il successivo 6 ottobre, dopo una possibile tappa a Zagarolo, il pittore era stato ospite di Marzio Colonna: fu durante questa sosta nei feudi Colonna, a Paliano piuttosto che a Palestrina, come talvolta riferito, che Caravaggio dipinse –secondo quanto indicato dalle fonti- una “Cena in Emmaus” e una “Maddalena in estasi”.
La “Cena” , invita dal pittore a Roma per essere venduta, tramite la banca Herrera e Costa, ai marchesi Patrizi che forse ne erano stati i commettenti prim’ancora della fuga nei feudi Colonna, era segnata nell’inventario dei dipinti appartenenti al marchese Costanzo Patrizi, redatto nel febbraio del 1624, e risulta presenta in casa Patrizi a Roma fino al 1939, allorquando, accogliendo una proposta indirizzata a tal fine da Ettore Modigliani, all’allora Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, non entrò a far parte delle raccolte della Pinacoteca di Brera. La tela fu infatti acquistata presso Patrizio Patrizi, con fondi raccolti tra gli Amici di Brera, integrati dai contributi di due mecenati milanesi. Questa opera, databile al tempo del soggiorno di Caravaggio presso i Colonna venne realizzata probabilmente a Paliano con un’essenzialità ed una rapidità di stesure pittoriche tali da evidenziare in alcuni tratti la preparazione sottostante e da far apparire alcuni particolari addirittura “non finiti” o appena abbozzati: con soluzioni che risulteranno sempre più accentuate nella sua produzione successiva alla fuga da Roma, anche per sue nuove sempre più sofferte e sempre più convinte concezioni dell’essere e dell’esistere, come del “fare pittura”.
La Cena in Emmaus di Brera presenta significative differenze sia stilistiche sia concettuali rispetto alla tela d’identico soggetto che Caravaggio dipinse nel 1602 per Ciriaco Mattei, transitata dopo il 1605 nella collezione di Scipione Borghese, presso i cui discendenti restò fino al 1801, per entrare poi a far parte delle raccolte della National Gallery di Londra nel 1839. Sulle evidenti differenti, non solo cronologiche ma anche sottilmente iconografiche, chiaramente iconologiche e decisamente stilistiche, che intercorrono tra le due versioni risulta ancora illuminante il contributo fornito da Mina Gregori e da Gerard Wolf con Hannah Baader nel catalogo della mostra presentata proprio a Brera nel 2009, a cura di Valentina Maderna e Amalia Pacia, dove ci fu la “messa a confronto” dei due dipinti: catalogo al quale si rimanda.
La Maddalena in estasi invece è segnalata per la prima volta insieme a due San Giovanni Battista in una lettera del nunzio apostolico a Napoli e vescovo di Capua, Deodato Gentile, indirizzata il 29 luglio del 1610 al cardinale Scipione Borghese a Roma. In questa lettera Gentile, annunciando la morte di Caravaggio avvenuta il 18 luglio, precisa che l’artista era partito da Napoli su una feluca con tre dipinti destinati in dono al cardinale e che, dopo l’arresto del pittore a Palo e il ritorno della feluca a Napoli, le tele si trovavano in casa della marchesa Colonna Sforza, allora ospite del nipote Luigi Carafa, nel Palazzo Colonna di Stigliano (poi Palazzo Cellamare) al Borgo di Chiaia. Di lì a pochi giorni, come risulta da un’altra lettera del 31 luglio inviata dal Gentile e sempre al cardinale Borghese, i tre dipinti tornati a Napoli, a causa della precedente espulsione di Caravaggio, per note vicende, dall’ordine dei Cavalieri di Malta e della conseguente confisca di tutti suoi beni, erano stati sequestrati dal priore dell’ordine residente a Capua.
Si sa che il Gentile –come anticipa in un’altra lettera del 26 agosto 1611- riuscì a far pervenire al cardinal Borghese solo il San Giovanni Battista seduto su una roccia con vicino un caprone (Roma, Galleria Borghese). Nessuna traccia invece della seconda tela con il Battista destinata da Caravaggio al Borghese: che è stata identificata o con una versione di una raccolta privata, nella quale il Santo viene raffigurato giovanissimo disteso su un manto rosso (purtroppo il dipinto è irrimediabilmente alterato da un esteso restauro, condotto in passato, che rende ormai impossibile riconoscerne l’autografia caravaggesca); oppure con un’altra composizione, con il santo ancora quasi fanciullo che si abbevera ad una fonte, della quale sono note varie versioni per lo più considerate copie o derivazioni con varianti, più o meno anonime, dell’originale finora non rintracciato (alcune sono state anche attribuite al napoletano Battistello Caracciolo o al siciliano di origine spagnola Alonso Rodriguez : cfr. Bologna 1991, Pacelli 1994, Marini 2001, Spinosa 2010).
Anche della Maddalena in estasi, che alla data del 31 luglio 1610 risultava temporaneamente presso il viceré di Napoli, conte di Benavente, si conoscono da tempo numerose repliche per lo più anonime. Sole eccezioni tre tele: due del franco fiammingo Louis Finson, originario di Bruges ed attivo a Napoli dal 1604-1605 al 1612 (la prima a Marsiglia, la seconda ora in collezione privata), la terza, firmata e datata 1620, di Wybrandt de Geest, cognato di Rembrandt (Barcellona, collezione privata).

In occasioni e tempi diversi si è anche proposto di identificare, sempre poco credibilmente, l’originale della Maddalena in estasi con dipinti anonimi presenti in consistente numero in varie raccolte private (una in una collezione palermitana, poi scomparsa; un’altra in collezione Klain a Roma –che è stato ipotizzato fosse la stessa presenta fino alla fine dell’800 presso i Carafa Colonna a Napoli- ; infine recentemente in una versione comparsa in collezione europea resa nota dalla Gregori ed esposta da Rossella Vodret a Tokyo).
E’ invece ancora inedita la Maddalena in estasi (fig 1) che Paolo Volponi comprò a Roma dall’antiquario Giorgio Pea nel 1987 che sembra rientrare nel consistente nucleo di derivazioni dall’originale caravaggesco che ne attestano comunque la notevole ed estesa fortuna.
In contrasto con quanti ne hanno finora identificato le note copie, comprese quelle firmate da Finson, della Maddalena in estasi di Caravaggio, datandola al suo soggiorno nei feudi Colonna, si è dichiarato – a mio parere convincentemente- Gianni Papi (2001-2004)il quale, basandosi oltre che su rilievi stilistici e precise concordanze con opere del secondo soggiorno dell’artista a Napoli, anche su possibili riscontri presenti nella documentazione d’archivio relativa alla collezione di Luigi Carafa, nipote della marchesa Colonna, resa nota nel 2013 da Antonio E. de Nunzio, ritiene invece che la Maddalena in estasi, presente con altri suoi dipinti sulla feluca partita da Napoli con Caravaggio e poi più volte copiata dallo stesso Finson (al punto da far supporre che quest’ultimo ne fosse entrato in possesso e l’avesse portata con sé dopo ave lasciato Napoli per Roma e poi per la Francia tra la fine del 1612 e gli inizi del 1613), non sarebbe stata realizzata nei feudi Colonna, ma negli ultimi mesi del suo secondo soggiorno in ambiente napoletano, in concomitanza, come confermano le affinità stilistiche, con la realizzazione di opere quali –tra le altre- il già citato San Giovanni Battista della Galleria Borghese, la Negazione di San Pietro del Metropolitan di New York e il Tiranno che trafigge Ursula (genericamente indicato come Martirio di Sant’Orsola) delle raccolte napoletane d’Intesa San Paolo a Palazzo Zavellos Stigliano.
Al punto da spingersi ad ipotizzare la possibilità che Caravaggio abbia dipinto due diverse redazioni della Maddalena in estasi. Una durante la sosta a Paliano, l’altra durante il secondo soggiorno napoletano, dalla quale deriverebbero le tante repliche firmate o anonime finora note.
Al di là di questa ipotesi di datazione e collocazione stilistica del prototipo caravaggesco della Maddalena in estasi, ciò che in questa sede interessa in particolare segnalare è che, in relazione al tema dell’ormai sempre più dilagante ed esteso “fenomeno” di riferire a Caravaggio opere spesso oscillanti tra la “copia anonima” o la “replica d’autore” di suoi originali, noti o ancora da rintracciare, un “filo rosso” collega il nome di Finson al pittore lombardo, non solo per le due citate copie della Maddalena in estasi, ma anche per altri due dipinti del Merisi documentati per qualche tempo a Napoli proprio nell’ atelier dello stesso Finson e del suo amico e “socio in affari” Abraham Vinck, documentato nella Capitale meridionale dalla fine del Cinquecento alla fine del 1612 o agli inizi dell’anno successivo. Si tratta della sontuosa monumentale ed affollata Madonna del Rosario appartenente alle raccolte del Kunthistorisches Museum di Vienna, di cui Finson avrebbe dipinto una copia messa in vendita ad Amsterdam nel 1631 dal mercante Charles de Koninck, e della Giuditta taglia la testa a Oloferne ricordata in lettere e documenti d’archivio e della quale si è da tempo indicata come probabile copia una tela (cm 140 x 161) appartenente alle collezioni di Intesa San Paolo esposte a Napoli in Palazzo Zevallos Stigliano ed assegnata anche di recente a Louis Finson.
Solo di recente è apparsa a Parigi, presso il Cabinet Tourquin, ma proveniente da un’antica dimora di Tolosa dov’era conservata almeno dalla metà dell’Ottocento, una tela con Giuditta taglia la testa di Oloferne (cm 144 x 173,5) quasi del tutto identica alla redazione del Banco di Napoli esposta a Palazzo Zevallos Stigliano.

Così da essere anch’essa messa in relazione con la Giuditta che, insieme alla Madonna del Rosario del Kunthistorische Museum di Vienna, era a Napoli come opera di Caravaggio sicuramente nel 1607. I due dipinti infatti sono segnalati a questa data in due occasioni: una prima volta in una lettera inviata da Napoli al duca di Mantova, Vincenzo Gonzaga, il 15 settembre dal suo agente e “fiduciario” Ottavio Gentile, che segnala di aver visto in casa di un pittore fiammingo (non cita il nome) “qualche cose di buone di Michelangelo Caravaggio che ha fatto che qui si venderanno” (non è indicato di quali opere si tratti, ma gli studi sono concordi, sulla base di altri riferimenti documentari, ad identificarle con la Madonna del Rosario e con la Giuditta di cui sopra); una seconda volta in una lettera del 27 settembre, inviata da Napoli sempre al duca di Mantova dal pittore fiammingo Frans Pourbus, nella Capitale del Viceregno per autenticare i dipinti del principe di Conca, che dice di aver “visto qui doi quadri bellissimi di mano di Michel Angelo da Caravaggio: l’uno è d’un rosartio et era fatto per un’ancona et è grande da 18 palmi et non vogliono manco di 400 ducati; l’altro è un quadro mezzano da camera di mezze figure et è un Oliferno con Giuditta, et non dariano a manco di 300 ducati. Non ho voluto fare alcuna proferta non sapendo l’intentione di Vostra Altezza, me hanno però promesso di non darli via sin tanto che saranno avvisati del piacere di Vostra Altezza” (cfr. Bodart 1970; Macioce 2003).

Ancora più evidente, quindi, rispetto alla lettera di alcuni giorni prima di Gentile al duca di Mantova, che Pourbus non solo faccia preciso riferimento, indicandone i soggetti e le dimensioni, alle due tele con la Madonna del Rosario a Vienna e con la Giuditta, identificata attraverso le due citate e identiche redazioni di Napoli e di Tolosa, ma che a vendere i due dipinti di Caravaggio fossero, per l’uso del plurale, almeno due proprietari. L’identità dei quali emerge chiaramente dalla lettera di un terzo e successivo documento riferibile alle due tele: il testamento redatto da Louis Finson in Amsterdam il 19 settembre 1617, a pochi giorni dalla scomparsa, con il quale lascia erede di tutti i suoi beni il pittore fiammingo Abraham Vinck, compresi i due dipinti con la Madonna del Rosario e con Giuditta dei quali dichiara di essere il comproprietario. Ed è noto che Vinck, a Napoli dalla fine del Cinquecento, qui aveva condiviso un atelier proprio con Finson , da quando quest’ultimo nel 1604 si era trasferito da Roma nella capitale meridionale. Più che probabile quindi che le due tele di Caravaggio segnalate al duca di Mantova da Gentile e da Pourbus fossero state viste in vendita proprio nell’atelier napoletano di Finson e di Vinck. Così come risulta evidente che partiti entrambi da Napoli tra la fine del 1612 e gli inizi del 1613 (Finson per recarsi in Provenza, Vinck per tornare in patria) abbiano portato con sé i due dipinti di Caravaggio, di cui sarebbero stati i comproprietari: dipinti che, come risulta dal testamento di Finson, ricompaiono ad Amsterdam dove quest’ultimo si ricongiunge con il suo amico e sodale di lunga data Abraham Vinck, nominandolo suo erede. Alla morte di Finson, della Giuditta si perde ogni traccia, mentre dopo il 1619, scomparso anche Vinck, la Madonna del Rosario viene acquistata per 1800 fiorini da una commissione di pittori e “amatori” fiamminghi, di cui faceva parte Pietro Paolo Rubens, e destinata ad essere collocata su un altare della chiesa dei Domenicani ad Anversa. Nel 1786, dopo una visita ad Anversa nel 1781 dell’imperatore d’Austria Giuseppe II d’Asburgo, che aveva espresso ammirazione per il dipinto, la Madonna del Rosario gli viene venduta, o donata, ed entra a far parte delle raccolte imperiali, per essere poi esposta nel Kunthistorische Museum.
Sulla base di rilievi stilistici, ma anche dell’ipotizzata identificazione del personaggio ritratto nella Madonna del Rosario, in ginocchio e in primo piano a sinistra, con il conte di Benavente, viceré di Napoli dal 1603 al 1610, (De Nunzio 204 e 2009), parte della critica si è oggi pronunciata per una datazione del dipinto al tempo del primo soggiorno napoletano di Caravaggio (Marini 2001). Ipotesi questa smentita muvendo da più estese ed approfondite considerazioni sulle qualità stilistiche della tela a Vienna, da quanti più convincentemente propendono per una sua collocazione alla fase finale dell’attività romana del pittore lombardo (Prohaska 2010).

Così come, sempre sulla base delle peculiarità stilistiche riscontrate nella copia della Giuditta ora esposta in Palazzo Zevallos Stigliano, la critica ha finora sempre sostenuto che l’originale considerato disperso fosse stato realizzato da Caravaggio a Napoli prima della partenza per Malta, alla metà del 1607. Anche perché nella Giuditta compare con caratteri somatici quasi identici, al punto da ipotizzare il riferimento ad una stessa modella, la vecchia col gozzo (probabile ripresa sia da un modello “dal vero” sia da un noto esempio della statuaria ellenistica) presente anche nella tela con il Sant’Andrea legato alla croce del Cleveland Museum of Art (fig 2), dipinto dal pittore lombardo per il viceré conte di Benavente durante il suo primo soggiorno napoletano. Di questa tela si conoscono tre copie: nel Museo de Santa Cruz a Toledo, nel Musee de Beaux Arts di Digione, assegnata sia a Finson sia a Vinck, in una raccolta privata svizzera proveniente dalla collezione Back Vega a Vienna (Carofano 2015), di recente considerata poco credibilmente opera autografa di Caravaggio.
In aggiunta la critica si è da qualche tempo orientata a ritenere anche la Giuditta di Palazzo Zevallos Stigliano, in passato assegnata anche ad Artemisia Gentileschi, copia dell’originale di Caravaggio realizzata proprio da Finson, presso cui –si è visto- era a Napoli, insieme alla Madonna del Rosario di Vienna, nel settembre 1607 e che, come ricordato, aveva anche copiato la dispersa Maddalena in estasi del pittore lombardo nelle due tele firmate del Musée de Beaux Arts di Marsiglia e di una raccolta privata (Leone de Castris 1984 e 2007; Capitelli et alii 2013). Di parere diverso Ferdinando Bologna (1992 e 2004) che, pur confermando la Giuditta di Palazzo Zevallos Stigliano come copia dell’originale caravaggesco dipinto, anche a suo giudizio, a Napoli tra il 1606 e il 1607, l’ha assegnata al cosiddetto Maestro dell’Emmaus di Pau, poi identificato, poco credibilmente, con il giovane Filippo Vitale da Giuseppe Porzio (Porzio 2012). D’altra parte risulta evidente a “chi sa vedere” senza fermarsi alla sola lettura delle carte d’archivio (che comunque bisogna “saper leggere”) che in nessun modo la Giuditta di Palazzo Zevallos Stigliano può essere stata dipinta da Finson.

Basta infatti metterla a confronto con mente ed occhi lucidi sia con le sue Maddalene firmate sia con altri suoi dipinti realizzati a Napoli pur muovendo da modelli di Caravaggio liberamente interpretati e rivisti (il Sansone e Dalila di Marsiglia fig 3, la Salomè con la testa del Battista di Braunschweig, la Resurrezione di Cristo del 1610 di Aix en Provence, la stessa pur notevole Allegoria dei quattro elementi, con firma e data 1611, e l’Annunciazione del 1612 per la distrutta chiesa napoletana di San Tommaso d’Aquino, oggi nei depositi del Museo di Capodimonte) per giungere alla conclusione che la tela di Palazzo Zevallos Stigliano non è altro che il risultato di un modesto e ancora anonimo copista di Caravaggio, le cui capacità di resa pittorica non toccano neppure i livelli qualitativi, peraltro non eccelsi, dello stesso Finson più caravaggesco.

Non è improbabile che, a prescindere dai risultati dei rilievi stilistici, quanti hanno optato per una datazione delle due tele al tempo del primo soggiorno napoletano del pittore lombardo, abbiano tenuto in considerazione, con eccessiva fiducia, anche quanto affermato da Gentile nella citata lettera al duca di Mantova: che i dipinti di Caravaggio visti a Napoli sarebbero stati da quest’ultimo qui eseguiti. Il che non significa necessariamente che entrambe le tele fossero state effettivamente realizzate proprio a Napoli e che almeno una delle due (verosimilmente la Madonna del Rosario) fosse stata qui trasferita da pittore lombardo, dopo la fuga a Roma e la sosta nei feudi Colonna).
Così come si è anche scritto che i due dipinti sarebbero entrati in possesso di Finson e Vinck per acquisto. Il che, senza avere alcuna implicazione sulla data di esecuzione delle due tele, starebbe solo ad indicare o che a venderle ai due fiamminghi sarebbe stato lo stesso Caravaggio in partenza per Malta, oppure che i due, ricevute le tele da Caravaggio, forse anche perché venissero vendute, le abbiano fatte passare come opere acquistate presso il pittore lombardo, in viaggio verso l’isola. In entrambi i casi, si tratta di due ipotesi che nessun rilievo hanno per la datazione sia della Madonna del Rosario sia della Giuditta taglia la testa di Oloferne. Mentre, comunque sia, messe a confronto la Madonna del Rosario e la Giuditta, anche se nota ora attraverso le identiche redazioni di Napoli e di Tolosa, che in nessun modo i due dipinti, segnati da marcate differenze stilistiche, possono appartenere a uno stesso momento dell’attività di Caravaggio.

Tuttavia mentre per la datazione della tela di Vienna la proposta più convincente resta quella di collocarla in prossimità della Madonna dei palafrenieri della Galleria Borghese o della Morte della Vergine al Louvre, più complesso è stabilire, invece, dove e quando Caravaggio dipinse la Giuditta attestata a Napoli, insieme alla Madonna del Rosario, nella bottega di Finson e Vinck nel settembre 1607, e poi ricomparsa ad Amsterdam nel 1617.

Un dipinto che in ogni caso, visto a Napoli, a Roma o, meno probabilmente, ad Amsterdam direttamente o attraverso alcune copie, trovò in breve notevole e prolungata “fortuna” se, oltre alla redazione di Palazzo Zevallos Stigliano, sono sicuramente ad esso ricollegabili alcune tele d’identico soggetto e con soluzioni compositive affini: una di collezione privata assegnata allo stesso Finson o ad anonimo napoletano (Spinosa, 2009) ma dal Papi assegnata al Maestro di San Silvestro, identificato col frisone Martin Faber, attivo per qualche tempo a Napoli e in Provenza con il pittore franco fiammingo (fig 4); oppure un altro dipinto di accentuata inclinazione caravaggesca con la Giuditta rivolta verso il riguardante come nelle due tele di Palazzo Zevallos Stigliano e di Tolosa, comparso presso la Galleria Porcini a Napoli e assegnato al cosiddetto Maestro dell’Incredultià di San Tommaso, forse Jean Ducamp (fig 5, Porzio 2016); o ancora, una tela di Filippo Vitale databile dopo il 1630, già

presso la Galleria Maurizio Nobile a Bologna (fig 6).
Una prima ipotesi per la Giuditta di Caravaggio vista a Napoli e ricomparsa ad Amsterdam può essere fornita dai risultati di un confronto iconografico e stilistico delle due identiche redazioni della Giuditta di Napoli e di Tolosa, rinviando per ora un giudizio critico sulla qualità e sulla identità della seconda, con l’altra nota versione dello stesso soggetto dipinta da Caravaggio per Ottavio Costa, banchiere di Albenga attivo a Roma: la Giuditta taglia la testa di Oloferne (cm 145 x 195) delle raccolte della Galleria Nazionale di Palazzo Barberini (fig 7), delle quali entrò a far parte, per acquisto nel 1971, proveniente dalla collezione di Vincenzo Coppi, presso la cui famiglia di origine si sarebbe trovata fin dagli anni quaranta del Seicento. Il dipinto, che a lungo la critica riteneva realizzato nel 1599, oggi, sulla base di dati documentari e di più estesi rilievi iconografici e stilistici, si data più convincentemente al 1602, dopo le tele per la cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo e in San Luigi dei Francesi (ma vicino alla seconda redazione del San Matteo e l’angelo per l’altare della stessa chiesa) e poco prima del San Giovanni Battista del Nelson Atkins Museum of Art di Kansas City, anch’esso dipinto per Ottavio Costa, e della Morte della Vergine (Cuppone 2016, anche per la bibliografia precedente e le diverse proposte di datazione).
Già il solo confronto iconografico tra la Giuditta Costa-Coppi di Palazzo Barberini e le due tele di Napoli e di Tolosa mostra evidenti e sostanziali differenze nella rappresentazione dello stesso episodio tratto dall’ Antico Testamento, anche rispetto alla narrazione contenuta nel testo biblico (Libro di Giuditta, 13,1-10). Nel quale si racconta –com’è noto- che, nel corso dell’assedio posto da oltre un mese alla città di Betulia, in Giudea, da un esercito assiro al comando di Oloferne, Giuditta, avvenente e ricca vedova rimasta per tre anni, dalla morte dl marito, sempre in casa indossando una veste nera, saputo che i Betuliani erano sul punto di arrendersi, si offrì di recarsi presso il generale assiro per ucciderlo. Ornatasi di gioielli preziosi e liberatasi dell’abito vedovile, si presentò a quest’ultimo accompagnata dall’anziana serva, Abra, recandogli doni e fingendo di voler tradire la sua gente. Oloferne, affascinato dalla bellezza della giovane donna, dopo averle offerto un lauto banchetto l’invitò nella sua tenda per possederla. Giuditta, mente il generale, ubriaco, era ancora disteso sul letto, gli mozzò la testa, bloccata per i capelli, e la depose nel sacco sostenuto dalla vecchia, rimasta in attesa all’ingresso della tenda per poi esporla trionfalmente agli abitanti di Betulia.
Nella tela dipinta per Ottavio Costa, di Giuditta, ripresa parzialmente di fianco, risultano privilegiate, pur nella rappresentazione dell’attimo di maggiore tensione del drammatico evento, le seducenti apparenze fisiche, evidenziate intenzionalmente dal contrasto con l’aspetto, al limite del grottesco, dell’anziana fantesca, ripresa di profilo, naso adunco, gozzo pronunciato e volto segnato da rughe profonde. Giuditta, agghindata con gioielli preziosi, indossa, per sedurre Oloferne, un’ampia sontuosa gonna di tessuto damascato, fermata sul davanti da una cordicella finemente annodata, insieme ad una sottile e trasparente camicia bianca, dalla larga scollatura rettangolare che mette in risalto la prorompente sodezza dei suoi prosperi seni. I capelli ramati, sono sapientemente raccolti sul collo e il bel viso tondeggiante è illeggiadrito dal raffinato orecchino con perla “a goccia”. I tre protagonisti sono rappresentati e bloccati su uno stesso piano, come in un altorilievo greco-romano, secondo un impianto ancora di matrice cinquecentesca. Il taglio delle luci e delle ombre definisce nitidamente concretezza e consistenza di forme e volumi. Le materie cromatiche, rischiarate e quasi preziose, dalle tonalità finemente accordate, sono sapientemente distribuite sulla tela con stesure larghe e dense. La resa di atteggiamenti espressivi e reazioni emotive è attenta, controllata e quasi contenuta.
Nelle due redazioni di Napoli e Tolosa, Giuditta è rappresentata invece in età più avanzata e con bellezza ormai matura di forme e apparenze.


Diversamente da quanto riferito nel testo biblico e riprodotto nella tela di Palazzo Barberini, indossa l’abito nero della vedovanza, anche se di raso o velluto prezioso, di taglio elegante e con riflessi in argento, su una camicia bianca con polsini finemente arricciati, che lascia solo di poco scoperto il pur florido seno. I capelli sono raccolti sotto un velo anch’esso nero e, come narrato dal testo biblico, sta mozzando la testa di Oloferne con un secondo colpo della spada rivolta verso l’alto, finemente decorata sull’elsa e sulla lama con motivi ornamentali ageminati in oro (nella versione Costa-Coppi è invece una daga rivolta verso il basso, con la lama convessa “alla francese”, più simile forse alla scimitarra di cui sembra si parli nella Bibbia). Le è accanto, come nella versione per Ottavio Costa, Abra, l’anziana serva (nel testo biblico, si è detto, rimasta fuori della tenda) con il viso sempre segnato da rughe ma più profonde, quasi incise simmetricamente, e con un’espressione non più di complice assenso, come nella tela di Palazzo Barberini, quanto piuttosto di evidente stupore ed intima preoccupazione per la temeraria fermezza della sua “signora”. Oloferne, anche qui disteso sul letto con le lenzuola disfatte, con la gola recisa e un fiotto di sangue, si agita urlando, tra la vita e la morte, sembrando ora più sconvolto dall’improvvisa aggressione, oltretutto subita dalla donna con la quale aveva avuto (o avrebbe voluto avere?) un rapporto amoroso, che dal dolore o dalla consapevolezza della morte imminente. Diversa è anche la definizione strutturale della tenda, con una resa più concreta e quasi misurabile dell’invaso spaziale, anche per la sapiente e scenografica disposizione della cortina di panno rosso, sontuosamente annodata in alto a sinistra, come nella Morte della Vergine al Louvre o nella Madonna del Rosario a Vienna, e sospesa a destra ad un palo di sostegno o a un tronco d’albero. Il fascio di luce che incombe da sinistra nella tenda, squarcia, come sulla scena di u nfosco dramma teatrale, le ombre dense e minacciose, sfiora le figure dei tre protagonisti(nella versione Costa-Coppi sfiora Oloferne ed investe frontalmente Giuditta con la vecchia serva) e le blocca in un legame, fisico ed emotivo, ancor più indissolubile di quanto non appaia nella versione del 1602. L’eroina biblica non è più intenta, come nella tela di Palazzo Barberini, a fissare, quasi con un senso di ripugnanza e di repulsione, la testa di Oloferne con la gola recisa. Ma come Giuseppe d’Arimatea nella Deposizione al Vaticano, ora si volge verso il riguardante e, dilatando tempi e spazi dell’evento oltre ogni limite imposto dalla narrazione dell’episodio e dalle dimensioni della tela, lo costringe ad essere testimone e complice –come in un dramma shakespeariano dalle tinte ugualmente fosche o corrusche– dell’eroica decisione presa e dell’efferato delitto che sta commettendo.
Evidente in ogni caso, al di là delle differenze segnalate, quanto la Giuditta nella versione lasciata da Caravaggio a Napoli insieme alla Madonna del Rosario ora a Vienna, prima della partenza per Malta, sia diversa da quella dipinta per Ottavio Costa. Diversa certo per scelte iconografiche, soluzioni compositive, resa pittorica e trattazione di stati d’animo come di reazioni espressive, ma soprattutto, perché riflette e documenta una mutata consapevolezza da parte del pittore, rispetto ai tempi della Giuditta ora a Palazzo Barberini, sul diverso significato che violenza e brutalità, insite nel delitto commesso dall’eroina biblica in nome della libertà del suo popolo e di se stessa da ogni forma di oppressione e sopruso, avevano assunto nel momento di redigere questa seconda versione del brano narrato nell’Antico Testamento: un episodio che ora, per questa sua seconda rappresentazione, dai toni più cupi e foschi, non è più letto e tradotto in immagini per il suo contenuto morale e il suo valore esemplare, secondo le interpretazioni e i “precetti” recenti di Santa Romana Chiesa, quanto rivisto e illustrato per le sue stringenti connessioni con l’irreversibile condizione dell’uomo, nel suo essere limitato ed esistere eterno, in un intreccio e succedersi costanti e indissolubili d’impennate e cadute, di ati d’esaltante eroismo come di gesti di efferata violenza.
Una nuova coscienza o “presa d’atto” della condizione dell’uomo, che Caravaggio venne acquisendo, in un alternarsi di lucido ottimismo e tetra disperazione, soprattutto a seguito delle successive esperienze di vita che culminarono nell’uccisione di Ranuccio Tomassoni e nella fuga da Roma nel maggio del 1606. Esperienze di vita che non potevano non segnare progressivamente , a partire dagli ultimi tempi del soggiorno romano e fino alla tragica scomparsa in un sanatorio di Porto Ercole, anche le sue inclinazioni e scelte di pittura: con esiti sempre più divergenti dalla soluzioni elaborate, sulla base di una diversa concezione dell’uomo, della natura, dell’essere e dell’esistere, come del fare arte, in anni immediatamente precedenti, tra fine Cinque e inizio Seicento. Proprio quando dipinse, in fitta successione, opere tra le quali, ad esempio, dopo le tele per la cappella Cerasi e per San Luigi dei Francesi, si colloca la prima versione della Giuditta taglia la testa di Oloferne per Ottavio Costa, da cui, si è visto, risulta tanto distante la seconda redazione della stessa Giuditta documentata a Napoli nel 1607 e ad Amsterdam nel 1617. Al punto che ne consegue quasi d’obbligo , di fissarne la datazione a qualche anno di distanza dalla versione ora a Palazzo Barberini: o poco prima della fuga del pittore da Roma o al tempo del suo primo soggiorno napoletano.
Nel primo caso la Giuditta, a Napoli nel 1607 e ad Amsterdam nel 1617, da identificare ormai con sufficiente certezza nella versione nota attraverso le due identiche tele di Palazzo Zevallos Stigliano e della raccolta privata di Tolosa, si collocherebbe, per concordanze stilistiche, dopo il San Giovanni Battista del Nelson Atkins Museum of Art di Kansas City, pure dipinto per Ottavio Costa, ma tra il 1603 e il 1604, e in prossimità soprattutto del San Girolamo del monastero di Monserrat, della Madonna dei pellegrini della chiesa di Sant’Agostino a Roma, del San Giovanni Battista della Galleria Corsini e del San Girolamo che scrive della Galleria Borghese sempre a Roma, della Morte della Vergine al Louvre.
A fissarne una collocazione durante il primo soggiorno a Napoli, dopo la realizzazione a Paliano della Cena oggi a Brera, sollecitano invece le non meno accentuate ed evidenti affinità con la Flagellazione di Cristo del Musée des Beaux Arts di Rouen, proveniente dall’eredità napoletana di Filippo Vandeneynden, le due Salomè con la testa del Battista del Palazzo Reale di Madrid e della National Gallery di Londra (quest’ultima riferita tuttavia anche al secondo soggiorno di Caravaggio) e, soprattutto, con la già citata tela con Sant’Andrea legato alla croce del Cleveland Museum of Art.
Personalmente pur con qualche dubbio propendo per la seconda ipotesi: anche perché emergono ben evidenti e rimarchevoli le concordanze riscontrabili tra questa seconda redazione della Giuditta e le tele di Caravaggio dipinte a Napoli tra il 1606 e il 1607. Soprattutto se il riscontro si basa sull’esame diretto della tela di Tolosa e sul confronto con la copia di Napoli: un esame diretto (quindi non basato sulle sole immagini fotografiche in circolazione sui media) che, dopo una serie di dettagliate indagini radiografiche, che ne hanno evidenziato qualche raro pentimento e una notevole rapidità di esecuzione, seguite da un parziale intervento di pulitura della superficie cromatica, non solo ha confermato della Giuditta comparsa in Francia il discreto stato di conservazione, ma –ciò che più conta- ha consentito di coglierne l’altissimo livello qualitativo sia rispetto alla copia (a mio giudizio ancora anonima) di Palazzo Zevallos Stigliano sia rispetto alle opere certe di Louis Finson , al quale anche la tela di Tolosa è stata da qualche parte inopinatamente assegnata. Al punto da farmi propendere –ma non sono il solo- a identificare la Giuditta “francese” con l’originale di Caravaggio visto nel 1607, insieme alla Madonna del Rosario, nell’atelier di Vinck e Finson, a Napoli e nel 1617 ad Amsterdam.

Convengo, tuttavia, che sia per assegnare con certezza alla mano del pittore lombardo la Giuditta di Tolosa sia per fissane una sua più convincente collocazione alla fine della sua attività in ambiente romano e al tempo del suo primo soggiorno napoletano, si rende quanto mai opportuno indispensabile un suo confronto o “dialogo” diretto con altri dipinti dell’ultimo Caravaggio tra Roma e Napoli; in particolare con tele come, ad esempio, la Madonna dei Pellegrini di Sant’Agostino a Roma e il Sant’Andrea legato alla croce del Cleveland Museum of Art.
Il telaio della Giuditta di Tolosa è di sicura manifattura francese del periodo napoleonico, così come la tela di rifodero applicata su quella originale, che , per la tessitura a trama larga, chiaramente visibile, è di sicura produzione napoletana del XVII secolo, ma era in uso spesso anche fuori Napoli e nella vicina Roma. Di rilevo la costatazione che il supporto originale è costituito, come quello della Giuditta di Palazzo Zevallos Stigliano, da due tele di diverse dimensioni cucite orizzontalmente all’altezza della mano sinistra di Oloferne e della destra dell’eroina biblica.
La superficie pittorica ha subito in un lontano passato (fine Ottocento o inizio Novecento?) uno o più interventi d conservativi, evidenti soprattutto nel lembo della tenda rossa all’estrema destra, sul retro della figura di Giuditta.

Alcune parti risultano realizzate come nella Cena in Emmaus di Brera, con stesure di colore rapide e di ridotta densità materica, come nei casi del lenzuolo che copre il letto su cui si agita riverso Oloferne, dell’abito in velluto nero e dei bordi della camicia indossati da Giuditta o del panno bianco che avvolge spalle e torace di Abra: al punto che in qualche tratto si nota ancora la preparazione sottostante.
Le indagini radiografiche condotte sull’intera superficie pittorica hanno evidenziato, come già accennato, pochissimi pentimenti, in parte già riscontarbili as vista, come, ad esempio, rispetto alla stesura iniziale, la riduzione della lunghezza della destra di Oloferne, una variante nella definizione del volume e nella collocazione del suo braccio sinistro; la diversa acconciatura dei capelli di Giuditta, che fuoriescono dal velo nero regolarmente sulla fronte, ma precedentemente dipinti “a riccioli”; o, sebbene non si tratti di un vero e proprio pentimento, quanto di una variazione decisa già “in corso d’ì’opera”, la stesura di un lembo del velo nero di Giuditta sulla tunica di Abra.
Da segnalare inoltre che su tutta la superficie del dipinto non sono state riscontrate tracce di quelle incisioni sulla preparazione individuate in altre opere di Caravaggio e, in particolare, nei suoi lavori giovanili (incisioni, peraltro, che alla fine del Cinque e nel primo Seicento non sono esclusi del pittore lombardo); tracce alle quali parte della critica recente ha attribuito così rilevante valore da essere considerate, non sempre a ragione, indizi inoppugnabili della sicura autografia di ogni altra presunta composizione, anche databile in anni e momenti diversi della sua attività.

Notevole in ogni caso, il livello qualitativo dell’intera composizione, quale emerge anche dallo studio e “messa a fuoco” di vari dettagli. Come, tra gli altri, il particolare, di altissimo effetto nell’evidenziare e accrescere il clima infuocato che avvolge la terrificante rappresentazione della violenta morte di Oloferne, della tenda rossa sontuosamente annodata in alto a sinistra e che evidentemente richiama, per affinità di soluzioni, il drappo rosso a fare da fondale alla scena di umanissima e concentrata tristezza della Morte della Vergine al Louvre o che incombe, annodato alla colonna, su quel grande “teatro dell’umanità” più vera trasferito sulla pala della Madonna del Rosario a Vienna. Così com’è altissima la trattazione della “mezza figura” di Oloferne, non diversa per vigore di modellato da una scultura d’età ellenistica, che, pur replicando nelle apparenze quella dipinta nella versione di Palazzo Barberini (identica la posizione della sua mano destra aperta e “bloccata” sul letto, a fare inutilmente da perno per tentare di voltarsi verso Giuditta e che significativamente anticipa o riprende la stessa posizione della mano destra, apparentemente poggiata sul vuoto, dell’angelo in volo nella Madonna della Misericordia al Pio Monte di Napoli) è per stesure e tonalità di colore, di un’immediatezza e di una verità anche più toccanti. Proprio come, anche rispetto alla Giuditta per Ottavio Costa, lo è la resa dei tratti del volto di Oloferne, sconvolto, urlante ma anche inferocito come una belva ferita a morte. Tutti rilievi che, insieme a pochi altri, (le mani di Giuditta, la sinistra della vecchia serva a reggere il sacco) evidenziano il diverso e più alto livello qualitativo della tela di Tolosa rispetto all’identica versione di Palazzo Zevallos Stigliano.
Certo, anche nella Giuditta di Tolosa non mancano, in alcuni tratti, soluzioni che possono alimentare dubbi e perplessità sulla possibilità che, nel caso, siamo finalmente di fronte all’autografo di Caravaggio scomparso ad Amsterdam e finalmente ritrovato. Tra tutti, la mano destra di Giuditta, forse in parte alterata da un malaccorto intervento conservativo, e il volto di Abra, segnato –si è già detto per la copia di Palazzo Zevallos Stigliano– da rughe profonde, dipinte tuttavia, con rigoroso schematismo, del tutto estraneo ai modi del pittore lombardo. Anche se, per apparenze somatiche, la vecchia serva di Giuditta sembrerebbe essere stretta “parente” o dell’anziana pellegrina inginocchiata dinanzi alla Madonna col Bambino nella citata pala di Sant’Agoatino a Roma o della pensierosa moglie dell’oste nella Cena in Emmaus di Brera e, soprattutto, non solo perché anche lei “gozzuta”, della vecchia ai piedi di Sant’Andrea sulla croce nella tela ora a Cleveland. Possibile che altre e più approfondite indagini sui pigmenti del volto della serva di Giuditta concorreranno in futuro a mettere in luce i motivi della soluzione adottata e che ancora lascia m i lascia perplesso.
Resta comunque al di là di questi marginali rilievi , che è proprio la disposizione delle mani di Giuditta e dell’anziana serva a costituire, insieme alla testa reclinata e solo in parte recisa di Oloferne, disperato e inferocito tra la vita e la morte, il nucleo centrale e altamente qualificante dell’intera composizione, più serrata di quanto non lo sia la versione per Ottavio Costa:

nucleo attorno al quale la tragica vicenda si è bloccata per sempre nel momento culminante di più drammatica tensione fisica, psichica e visiva. Con una resa così concreta e concentrata del dato reale, soprattutto con una così partecipe e sofferta rappresentazione dell’evento raffigurato, rispetto alla stessa versione realizzata per Ottavio Costa, quale rare volte si riscontra, allo stesso altissimo grado di umana tensione, in altri dipinti di Caravaggio datati o databili subito dopo le tele del 1600 per San Luigi dei Francesi e poco prima della precipitosa fuga da Roma nel maggio del 1606.
Sicché, per qualità indicate, è da escludere che nel caso della Giuditta di Tolosa si possa essere dinanzi a un’altra copia dell’orignale visto a Napoli e poi ricomparso ad Amsterdam, da assegnare, semmai, anche nel suo caso, come per la copia di Palazzo Zevallos Stigliano, al “solito” Finson, come pure da qualche parte si è tentato di proporre, e che da qualche tempo è diventato ormai il “contenitore” preferito della gran parte di quei dipinti anonimi che di volta in volta sono messi in relazione con originali dell’ultimo Caravaggio dispersi o ancora non identificati.
E allora, come affrontare e pensare di risolvere quello che ormai si configura, anche nel caso della Giuditta taglia la testa di Oloferne ritrovata a Tolosa come un “giallo” poliziesco di difficile soluzione? Forse qualche contributo in tal senso può essere arrivato, a “voler e saper vedere”, in seguito alla sua presentazione per la prima volta in Italia a Brera, accanto alla Cena in Emmaus alla Maddalena di Marsiglia firmata proprio da Finson e alla copia della stessa Giuditta di Palazzo Zevallos Stigliano. Che è quanto seppur con qualche dubbio tutti ci auguriamo.
di Nicvola SPINOSA





