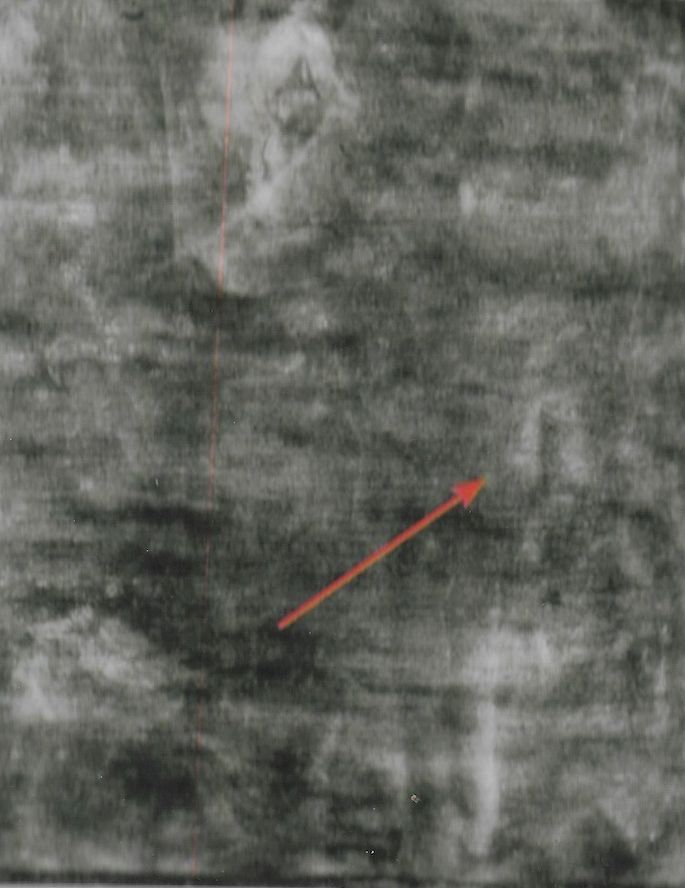di Gianni PAPI
Qualche riflessione sulla mostra milanese Dentro Caravaggio*
La mostra su Caravaggio che si è svolta agli inizia di gennaio a Milano ha avuto innegabili meriti; curata da Rossella Vodret, aveva già nel titolo Dentro Caravaggio quello che è stato il suo principale intento: svelare l’iter esecutivo del pittore[1].
Ben venti opere del Merisi erano presenti: data la difficoltà nel concedere prestiti così importanti, immagino quale sarà stato l’enorme lavoro diplomatico per la preparazione dell’evento, tanto che in occasioni come questa – ben più rispetto ad altre mostre – il progetto giocoforza si consuma tutto nella ricerca di ottenere il maggior numero di prestiti. E alla fine non è troppo grave se fra quei venti dipinti ne saranno mancati alcuni che la curatrice avrebbe voluto, ma che erano – per le più varie ragioni – incedibili: l’importante è aver raggiunto quel numero sorprendente e che tutte le opere fossero (salvo poche eccezioni meno sicure, un paio al massimo) indiscutibili sul piano dell’autografia.
La mostra di Milano, con la sua specificità riguardante il modo di dipingere del Merisi, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel separare lo studio del pittore lombardo dal resto della storia dell’arte. Ormai Caravaggio appare come un settore della disciplina a se stante, per il quale si affilano sofisticati strumenti tecnologici e si trascorrono mesi e anni in archivio.
Caravaggio viene studiato a tutto campo, in modo oserei dire quasi morboso, con una serie variegata di metodologie e con un accanimento nel voler ricostruire ogni aspetto della sua attività e della sua vita, che non hanno riscontro – se non in piccola parte – negli studi dedicati ad altri protagonisti della storia dell’arte e del Seicento in particolare. Tutti gli sforzi che si fanno intorno a Caravaggio – da parte di decine e decine di studiosi in tutto il mondo e particolarmente in Italia – hanno forse paragone rispetto a ciò che accade, ad esempio, intorno a Rubens o a Velázquez, per citare due sommi epigoni del lombardo? E in questi ultimi quindici anni, seguiti alla rivoluzionaria scoperta dell’attività romana di Ribera, si è forse avuto un particolare interesse per indagare il contesto dei committenti e i molti lati della personalità di colui che gareggia col Merisi per genialità e sempre più ci appare come il pittore che ha dato nuova linfa alla corrente naturalistica originata da quest’ultimo?
Come ho detto all’inizio, la ragione principale della mostra di Milano è stata quella di spiegare in modo chiaro e senza appesantimenti la tecnica di Caravaggio, sulla base delle analisi cui sono stati sottoposti i venti dipinti riuniti, analisi che sono state compiute con mezzi sempre più raffinati nel corso degli ultimi anni e in alcuni casi appositamente per la mostra. Tuttavia, al di là di questo aspetto su cui più avanti mi soffermerò, l’esposizione è stata una straordinaria occasione per vedere nel dettaglio e talvolta come non si erano mai viste le superfici delle venti opere (Davanti a Caravaggio almeno quanto Dentro Caravaggio potrebbe essere stato, paradossalmente, il giusto titolo della mostra): questo per merito di un allestimento ordinato e suggestivo, e soprattutto di un’illuminazione miracolosa, che è riuscita a eliminare ogni brillìo e ha dato perfetta uniformità alla luce che rischiarava le opere, in ogni centimetro di esse. Alcune in particolare sono state una sorta di rivelazione per me, che pure le avevo viste molte volte: dal Riposo nella fuga in Egitto Doria alla Flagellazione di Capodimonte, dal Ragazzo morso da un ramarro Longhi al San Giovanni Battista Corsini, fino alla Sacra Famiglia di collezione privata, in deposito presso il Metropolitan Museum. Ciò ha suscitato fruttuose riflessioni e nuovi interrogativi riguardo al percorso del pittore e alla cronologia di alcune opere; fosse anche solo per questi meriti (per l’eccezionale visibilità dei dipinti e per la loro cospicua presenza), la mostra avrebbe avuto già la sua necessità e la sua ragione di essere.
Per quanto riguarda il motivo principale dell’esposizione, cioè la presentazione delle analisi tecniche relative ai venti dipinti e da lì l’indagine sulla tecnica pittorica del Merisi, credo siano da fare alcune riflessioni. La prima si riallaccia al discorso fatto all’inizio: da molti anni si indaga sulle procedure esecutive del pittore, con una tale determinazione che non ha confronti con nessun altro collega della stessa epoca. Proprio questo punto può denunciare qualche debolezza nell’operazione, perché se si indagasse con la stessa decisione l’opera di altri artisti forse si potrebbero scoprire analogie e vicinanze, o magari si potrebbero stabilire in modo più realistico le differenze: mi riferisco in particolare a quelli prossimi a Caravaggio, ad esempio Ribera o Battistello Caracciolo o Spadarino (solo per fare qualche nome dei molti che si potrebbero analizzare), o magari, allontanandosi, a Giovanni Baglione e ad Annibale Carracci.
Un’altra riflessione la pone la sicurezza con cui nel catalogo vengono presentati i risultati delle analisi tecniche. La loro interpretazione, fornita in quelle pagine, viene proposta come certa e in qualche modo incontrovertibile. Allo stesso tempo proprio l’insindacabilità di tale interpretazione, dichiarata come ‘scientifica’, ha come implicito traguardo quello di chiudere il dibattito, animato da decenni dalle tradizionali analisi stilistiche fornite dall’occhio e dalla sensibilità dei conoscitori del pittore.
Io credo che le analisi tecniche, come ogni altro strumento di conoscenza, siano un supporto da valutare insieme ad altri e dovrà essere poi lo studioso a giungere a una sintesi e a un giudizio complessivo sull’opera in questione. A questo proposito mi paiono significativi due esempi di segno opposto che la mostra propone.

Il primo esempio, che è anche rappresentativo di una certa disomogeneità fra le varie voci che compongono il catalogo, riguarda il San Francesco in estasi di Hartford, eseguito da Caravaggio per Ottavio Costa (fig. 1).
Nella scheda stilistica e in quella tecnica (leggibile nel CD allegato al catalogo) la datazione proposta per l’opera è 1595-1596, secondo la tradizionale collocazione cronologica del dipinto, precedente alla rivoluzione seguita alla ricostruzione degli anni giovanili del pittore a Roma compiuta dal team della mostra del 2011 Caravaggio a Roma. Una vita dal vero[2]. Tale ricostruzione, che prevede l’arrivo del Merisi alla fine del 1595 o all’inizio del 1596 (anziché, come da decenni sembrava stabilito, alla fine del 1592 o all’inizio del 1593), e l’ingresso presso il palazzo del cardinal Del Monte solo a partire dal giugno-luglio del 1597, è pienamente sposata dalla curatrice Vodret e nel catalogo si dà ampio spazio a saggi che tale proposta hanno avanzato o ribadiscono (Curti, Verdi, Gandolfi, Zuccari e la stessa Vodret).
Come si spiega allora la datazione 1595-1596 sulle schede?
D’altra parte la Vodret[3], forte dei risultati tecnici (preparazione bruna, visibile nei profili di contorno e presenza di insistite incisioni nel panneggio dell’angelo), non esita a cambiare la collocazione del quadro (normalmente visto come opera giovanile, dove ancora si riscontrerebbero le tracce dell’influenza lombardo-veneta suscitata dalle opere di pittori come Savoldo e Lorenzo Lotto) e lo data a ridosso della cappella Contarelli (almeno 1598). Ora è vero che la nuova ricostruzione degli anni romani, che per molti aspetti appare convincente (a partire dalla sua prima presentazione da parte di Francesca Curti e vieppiù con la mirabile sintesi proposta da Orietta Verdi nel saggio in catalogo)[4], comprime l’esecuzione dei dipinti giovanili di nostra conoscenza in pochissimi anni, fra il 1596 e il 1599. Tuttavia rimane sempre il problema della sequenza e mi risulta molto difficile collocare il quadro di Hartford dopo la Medusa o più o meno in contemporanea con essa (che come si sa il 7 settembre 1598 era già eseguita[5], questo rimane a tutt’oggi l’unico riferimento cronologico sicuro di questi anni giovanili, quanto mai tormentosi per gli studi caravaggeschi).
Il quadro di Hartford mi pare vicino ai Musici Del Monte del Metropolitan Museum e ai Bari, così come alla Buona ventura Vittrice del Louvre, che peraltro ora viene datata dalla Vodret – sempre per i motivi tecnici – prima della versione Capitolina (quest’ultima proposta alla fine del 1596 nella scheda in catalogo di Sergio Guarino, ma dalla Vodret nella seconda metà del 1597), scelta che non mi sento di condividere. In sostanza mi pare che l’adeguamento al nuovo scenario (compresso) degli anni giovanili, fra l’inizio del 1596 e il luglio 1599, quando Caravaggio comincia la prima versione (poi coperta) del Martirio di san Matteo, provochi qualche problema e forse il catalogo avrebbe dovuto maggiormente approfondirne la dialettica e dar conto, magari giustificandole e armonizzandole, delle divergenze presenti nelle sue pagine.
Un caso opposto, in cui a mio avviso le analisi tecniche spingono a cambiare in modo fruttuoso (almeno a mio parere) una cronologia assodata, è quello del dipinto di Detroit con Marta e Maria Maddalena (fig. 2).

Da tempo sono propenso, giudicando solo su base stilistica, a posticipare la datazione del dipinto – di solito collocata intorno al 1598 (come del resto nella scheda in catalogo), quindi almeno un anno prima della Contarelli – in un momento più tardo, contemporaneo all’impegno per San Luigi dei Francesi o addirittura posteriore. Ora Vodret, in forza delle conclusioni suggerite dall’analisi delle pennellate chiare dell’abbozzo e delle incisioni, sposta l’esecuzione al 1599 e anche oltre.
Lo stesso accade per la Giuditta Costa oggi presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma (fig. 3).

Già dal 2010 ho proposto una datazione successiva alla Contarelli[6] e più recentemente ho collegato l’esecuzione del dipinto al documento recuperato da Maria Cristina Terzaghi, datato 21 maggio 1602, in cui Caravaggio dichiara di ricevere da Ottavio Costa venti scudi “a bon conto d’un quadro ch’io gli dipingo”. La studiosa lo aveva invece messo in relazione col San Giovanni Battista oggi a Kansas City[7] (fig. 4). Anche in questo caso il referto tecnico, sottolineato dalla Vodret (“significato e ruolo delle incisioni e, soprattutto, il nuovo uso degli abbozzi chiari”), spinge la curatrice a posticipare l’esecuzione dell’opera a dopo le tele Contarelli e a convenire con la corrispondenza col documento del 1602.

In merito alla sicurezza con cui vengono interpretate le tracce offerte dalle analisi tecniche, e in particolare dalle radiografie, mi parrebbe più giusto che venisse dichiarato che – almeno in diversi casi – si tratta di interpretazioni; la presentazione ‘scientifica’ di tali interpretazioni può apparire a volte eccessiva e troppo assertiva.

Scorrendo le pagine del catalogo e il CD allegato posso fare subito tre o quattro esempi. Il primo riguarda l’opera forse più incerta (sul piano dell’autografia) che si può vedere a Milano, datata dalla Vodret con sicurezza (a mio avviso senza una sufficiente spiegazione sul piano stilistico e senza elementi documentari per poterlo affermare) nel 1606, durante la sosta a Paliano. Mi riferisco al San Francesco in meditazione di Carpineto, oggi conservato presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini (fig. 5).
Per molti anni si è voluto vedere nella radiografia del dipinto la precedente esecuzione di una figura del santo più piccola, una sorta di prima idea[8]; e anche ora si ripropone tale identificazione (nella scheda tecnica del catalogo e in quella leggibile nel CD, compilata da Marco Cardinali), affermando che la figura appare di dimensioni ridotte della metà. Ma la Vodret nel suo saggio parla di cose ben diverse: giustamente a mio avviso la studiosa vede ora due mani – più grandi di quelle della versione definitiva – che a destra tenevano il teschio (che viene riconosciuto come “più piccolo di quello attuale”, ma chi scrive non riesce a vederlo), e non accenna più al San Francesco di dimensioni dimezzate che starebbe al centro della prima idea compositiva.
Un altro caso è rappresentato dal Riposo nella fuga in Egitto Doria (fig. 6).

Con sicurezza si avvista in radiografia (fig. 7), in una piccola figura a destra – forse da scorgere in alcune linee di biacca che potrebbero far pensare a un corpo ma di misure davvero modeste, piuttosto una statuina – una prima idea per l’angelo, che sarebbe poi stato portato al centro della composizione e fatto diventare di dimensioni gigantesche (rispetto alla presunta prima idea). Tale interpretazione mi pare di difficile percorribilità, così come mi pare arbitrario dichiarare che le tracce di biacca al centro della radiografia indichino una precedente collocazione del gruppo della Madonna col Bambino, che sarebbe stato spostato a destra nella versione che vediamo oggi; mentre si sorvola, non citandole, sulle strane linee di biacca parallele che si possono vedere in radiografia a sinistra in basso, una di esse si raccorda, formando un ovale, con lo svolazzo del drappo bianco dell’angelo; né si sottolinea che proprio a quell’altezza la parte mediana della gamba dell’angelo ha un evidente accentuazione di biacca, di difficile interpretazione.
Continuando con la sicurezza con cui vengono interpretate le radiografie, mi pare piuttosto arbitrario pensare che in una traccia di biacca non lontana dal volto del Ragazzo morso dal ramarro Longhi possa vedersi una prima idea della mano spaventata oggi posizionata all’estrema destra[9] (figg. 8-9).


Non c’è poi alcuna certezza per pensare che la massa di biacca che si vede in radiografia a fianco del San Giovanni Battista Corsini (figg. 10-11) debba corrispondere alla presenza dell’agnello, che secondo la Vodret sarebbe stata poi ripensata e cancellata nella stesura definitiva.

Largo spazio nelle discussioni tecniche è preso dalla questione dell’importanza data da Caravaggio al colore della preparazione, utilizzato come una vera e propria campitura cromatica; col passare del tempo e col progredire dell’attività tale pratica di ‘riduzione’ della materia pittorica giungerebbe al suo acme nel finale Martirio di sant’Orsola (primavera 1610, a Napoli), dove la gran parte della superficie non sarebbe ‘dipinta’ nel senso tradizionale, ma solo ottenuta con la preparazione nera, e le pennellate si ridurrebbero alle zone più chiare e colorate: il volto della santa sarebbe insomma risolto con poche pennellate bianche. Io credo che per il dipinto di Palazzo Zevallos si dovrà anche considerare lo stato di conservazione molto compromesso e credo che la tela, quando, nella primavera del 1610, fu imbarcata da Lanfranco Massa alla volta di Genova, avesse un aspetto diverso rispetto a quello che vediamo oggi.
Le conclusioni sul ruolo sempre più esteso che il pittore avrebbe assegnato alle preparazioni fino a giungere a tali estremi, mi destano qualche perplessità. Un esempio, che mi parrebbe in contrasto con queste conclusioni, è trascurato dal catalogo. Il recente restauro della Salomè del Palazzo Reale di Madrid[10] (fig. 12), opera che a mio avviso (e non solo mio) è da assegnare al secondo soggiorno napoletano, nel 1609-1610, ha messo in luce un bellissimo fondo verde scurissimo mescolato a marrone, brillante e tutt’altro che ‘fermo’ cromaticamente, che non mi sembra possa essere definito mera ‘preparazione’. Eppure il quadro è ugualmente finale, proprio come la Sant’Orsola.

Molto importante pare altresì, sempre in merito a questo argomento, quanto rileva Claudio Falcucci nel suo saggio[11]. Non è ancora una certezza, perché basata solo su una campionatura limitata, ma si tratta di un’importante apertura, sul particolare trattamento della preparazione nell’ottica compositiva di Caravaggio. Non solo essa verrebbe utilizzata come vera e propria campitura pittorica in alcune parti dell’immagine (e il pittore concederebbe ad essa un’attenzione non minore rispetto alla successiva, vera e propria stesura finale), ma Caravaggio – in previsione delle aree cromatiche con cui darà vita al dipinto – modificherebbe le tonalità della preparazione a seconda di tali previsioni. Nello stesso dipinto insomma, ci sarebbero aree di preparazione modificate cromaticamente da zona a zona, utilizzate, oltreché per determinare la tonalità della successiva stesura, anche come aree di colore finale che si alternano (in misura più o meno cospicua) alla pittura definitiva.
D’altra parte, a conferma dell’incertezza che domina ancora le disquisizioni ‘scientifiche’, lo stesso Falcucci mette in crisi un assunto che in quasi trent’anni di analisi tecniche era data ormai per verità acquisita: che la preparazione dei quadri di Caravaggio gradualmente diventasse sempre più scura col procedere della sua attività. Secondo questa tesi, da molto chiara nei quadri cinquecenteschi, la preparazione diventava poi rossa o marrone nei quadri secenteschi romani e poi via via sempre più scura e nera. Falcucci, rovesciando questa ormai scientificamente divulgata credenza, afferma testualmente:
“Anche la spesso citata distinzione generica, che vorrebbe preparazioni chiare per i dipinti giovanili, scure per quelli successivi, non trova riscontro in una ricerca più sistematica attraverso le osservazioni e i dati analitici. Se è infatti vero che le preparazioni di colore grigio chiaro vengono abbandonate prima del volgere del secolo, a eccezione della Conversione di Saulo oggi in collezione Odescalchi, le preparazioni scure sono già ampiamente utilizzate da Caravaggio prima (o contemporaneamente) delle due citate tele su preparazione chiara della Galleria Borghese [il Bacchino malato e il Ragazzo con canestro di frutta]: i Musici di New York, il Suonatore di liutodell’Ermitage, le due versioni del Ragazzo morso dal ramarro di Londra e di Firenze, il San Francesco di Hartford sono tutti su preparazione scura”[12].
Chiudo queste riflessioni con l’ultima riguardante alcuni saggi in catalogo, che esprimono un grande sforzo nel capillare recupero dei contatti e della trama di relazioni che Caravaggio può avere avuto a Milano, a Roma, a Napoli, a Malta; e non solo di Caravaggio, ma anche di altri personaggi legati al Merisi si tenta di ricostruire un intreccio di rapporti. Il pericolo a mio avviso può essere quello di giungere, magari in qualche caso, a conclusioni forse un po’ forzate, poiché l’essere presenti in uno stesso documento non sempre vuol dire un’amicizia duratura e profonda, così come una parentela non significa sempre un legame stretto: leggendo tutto d’un fiato quei saggi in catalogo si ha l’impressione che tutti conoscessero tutti, in un continuo e vorticoso rimando di contatti, di parentele, di vincoli affettivi e di affari. Ancora più scivoloso mi pare il campo dei rapporti con gli intellettuali; da una certa data in poi – leggendo in particolare il saggio di Sybille Ebert Schifferer[13] – sembra che Caravaggio non abbia fatto altro che frequentare persone di rango elevato e intellettuali. Davvero si resta perplessi a p. 293, quando la studiosa tedesca afferma che l’osteria del Cerriglio a Napoli era un ritrovo di letterati e il Merisi, non a caso, l’avrebbe frequentata[14]. Ma una serie di documenti e testimonianze segnalerebbero tutt’altro clima: il Cerriglio sarebbe stata una osteria malfamata, che veniva frequentata per la prostituzione femminile, e, più segretamente e forse soprattutto, per quella maschile[15].
Gianni PAPI dicembre 2018
*Il presente saggio è inserito nell’ultimo volume di Gianni Papi Senza più attendere a studio e a insegnamenti. Scritti su Caravaggio e l’ambiente caravaggesco,editore artstudiopaparo (Napoli, 2018). Siamo grati all’autore e all’editore arstudiopaparo per aver gentilmente concesso ad About Art la pubblicazione in anteprima. A questo saggio farà seguito prossimamente la pubblicazione di una conversazione con l’autore considerata l’importanza degli argomenti trattati nel volume.
NOTE