di Mario URSINO

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, prima del Gattopardo, nel Ricordo di Francesco Orlando, e qualche nota sul significato e l’iconografia delle sue opere
Nell’estate del 1957, sessanta anni fa, moriva tristemente a Roma, dopo breve e rapido male incurabile, l’autore de Il Gattopardo, in casa della cognata Olga von Wolff-Stomersee, moglie del diplomatico italiano Augusto Bianchieri Chiappori. Perfettamente consapevole della sua grave situazione, lo scrittore avrebbe desiderato tornare nella sua Palermo, ma non fece in tempo, come non fece in tempo a vedere pubblicato il suo capolavoro, edito nel novembre 1958 e vincitore del premio Strega il 7 luglio 1959, quindi a circa due anni dalla sua scomparsa. L’ambito riconoscimento per ogni scrittore fu assegnato al Tomasi in concorrenza con autori del calibro di Mario Praz, con il famoso La casa della vita, e Pier Paolo Pasolini con Una vita violenta.

Un’esistenza drammatica quella del principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo 1896-Roma 1957) [fig. 1], in fondo poco nota al grande pubblico che però aveva acclamato universalmente la bellezza del suo “romanzo storico”, anche perché si era facilmente confusa la sua persona di aristocratico con la grandiosa figura di Don Fabrizio Corbera di Salina, il principe protagonista della sua storia, narrativamente svoltasi tra il 1860, con lo sbarco dei Mille in Sicilia, e la morte del principe nel 1883, simbolo della sconfitta definitiva della classe feudale non solo in Sicilia, ma in tutta l’Europa, secondo l’interpretazione dello stesso Lampedusa. Ma questo significato dello scrittore, non fu immediatamente percepito dal pubblico e dalla critica, che aveva collocato Il Gattopardo nella categoria generica di romanzo storico, nella tradizione dei Verga, dei De Roberto, e persino di Pirandello, per le loro opere di espressione letteraria a forte tinta ambientale – regionalista.
In realtà per Lampedusa non è così. Già nelle primissime biografie dello scrittore, per esempio quella di Andrea Vitello, I Gattopardi di Donnafugata, 1963, leggiamo che la principessa di Lampedusa, moglie del Tomasi, Alexandra von Wolff-Stomersee (1894-1982) [fig. 2], di origine baltica, affermava perentoriamente: “Don Fabrizio è nei gusti, nei modi e nelle abitudini il contrario di mio marito” (p.215). La vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è stata, infatti, segnata da molti travagli, come attestano anche diversi biografi successivi (David Gilmour, per esempio, nel 1989), ma ancora più incisivamente suo figlio adottivo, Gioacchino Lanza Tomasi, nella sua Introduzione e nelle Premesse alle Opere dello scrittore, riunite nel grosso volume dei Meridiani della Mondadori del 1995 e successive ristampe, con revisioni critiche e aggiunte in appendice di inediti materiali di lavoro dello scrittore siciliano.
* * *
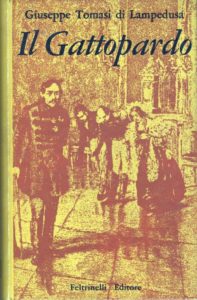
Il fatto è che, a rendere quella sorta di identità autore-personaggio, certamente dovette essere il grande successo internazionale del film, apparso nel 1963, Il Gattopardo, di Luchino Visconti, altro aristocratico che narra per immagini il già famoso romanzo, scritto da un discendente di antica e alta nobiltà; ma Visconti era un personaggio ideologicamente impegnato a sinistra, ragion per cui per gli stessi critici e intellettuali che cinque anni prima non avevano compreso la singolarità del romanzo, da quel momento esso divenne oggetto di interesse. (cfr, Stenio Solinas, Lampedusa, il profeta che la sinistra rifiutò di ascoltare, in “Il Giornale”, 20 luglio 2017).
Naturalmente, come tutti, andai al cinema per vedere il capolavoro di Visconti; avevo già letto per la prima volta, da adolescente, Il Gattopardo, in una delle primissime edizioni della Feltrinelli [fig. 3], trovata nella casa dove ero ospite nella caldissima estate del 1959 o del 1960, durante le lunghe vacanze estive dalla scuola (allora duravano da giugno ad ottobre), in una cittadina della Calabria Jonica, un tempo principesco feudo della potente famiglia Carafa di Roccella, (a quel tempo la piccola città era ancora immersa in aspre e arcaiche atmosfere con le antiche case di pietra e i palazzetti nobiliari e neo-borghesi: l’orribile cementificazione del nostro sud non era ancora iniziata, né esisteva la saturazione automobilistica odierna, che ha provocato la scomparsa di quei suoi intensi, aromatici profumi agresti mescolati dai venti marini e collinari, da me percepiti come un magico Eldorado, e chiedo venia per il mio inserto autobiografico); e quindi non tardai ad intuire, sebbene ancora ragazzo, che quelle mie percezioni visive e ambientali durante la lettura del Gattopardo non dovevano essere molto diverse dai paesaggi dalla Sicilia descritta dal Tomasi: infatti mi dovette colpire, sia pure inconsciamente, un brano del capitolo settimo, La morte del Principe, allorquando il protagonista Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina: “Era arrivato la mattina da Napoli poche ore fa; vi si era recato per consultare il professor Semmola… [terribile analogia del reale viaggio a Roma dello scrittore Tomasi per farsi visitare dal professor Valdoni nell’estate del 1957, n.d.a.]. Aveva preteso di ritornare per via di terra: decisione improvvisa che il medico aveva cercato di combattere; ma lui aveva insistito […]. Col risultato di dover poi rimanere trentasei ore rintanato in una scatola rovente, soffocato dal fumo delle gallerie […]. Si attraversavano paesaggi malefici […] quei panorami calabresi e basilischi che a lui sembravano barbarici, mentre di fatto erano tali e quali a quelli siciliani” (p. 286). Nella finzione narratologica, il principe di Salina viaggiava nel luglio del 1883, ma in realtà lo scrittore, verosimilmente, descrive lo stato dei paesaggi del sud italiano, osservato dai treni del 1957 da Roma, da Napoli a Palermo. Ma questo è solo uno dei tanti aspetti del romanzo che, raccontando negativamente l’Italia post-risorgimentale, aveva di fatto descritto il paese di un secolo dopo, con tutti i problemi legati alla ripresa post-bellica, considerati dallo scrittore siciliano con grande scetticismo. Il lettore non professionale, quale anche io ero al tempo della prima lettura, preso dall’avvincente storia romantica, percepisce con difficoltà l’autentica modernità dello stile narrativo dell’autore, che consiste in quei rapidi inserti “analessici” o “prolessici” (per usare termini della critica linguistica) che però non alterano il ritmo del romanzo storico nell’alludere al tempo presente in un contesto passato, o viceversa ad un evento futuro, come nell’esempio sopra riportato.
* * *
Lo studio più recente sullo stile letterario di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è un approfondito testo di analisi intertestuale di Maria Antonietta Ferraiolo, L’Opera-Orologio. Saggi sul Gattopardo, Pacini Editore, Palermo 2017 [fig. 4], suscitato dalle stesse teoriche affermazioni dello scrittore sulle letterature inglesi e francesi nelle sue Lezioni, anch’esse pubblicate postume. Ecco cosa il Tomasi scrive nel suo famoso lungo saggio sull’amatissimo Stendhal (pubblicato la prima volta su “Paragone” nell’aprile 1959): “in un romanzo ci dovranno particolarmente interessare il modo di esprimere il tempo, di concretizzare la narrazione, di evocare l’ambiente, di trattare i dialoghi […]. È come smontare un orologio: osservando nel loro giusto ordine le mollette, le ruote dentate, gli scatti, le viti e i perni vi rendete conto di come avvenga il movimento” (In Opere, cit. p. 1888). Oltre a questo acuto lavoro intertestuale della Ferraiolo, va ricordato anche quello del maggior allievo del Tomasi, Francesco Orlando (1934-2010), L’intimità e la storia. Lettura del Gattopardo del 1998 [fig. 5], un’indagine paziente (al limite della ossessività), una sorta di “autopsia” letteraria, se così si può dire, che il noto docente della Normale di Pisa ha condotto con gli strumenti del freudismo e dello strutturalismo, ovvero, semplificando, che l’autonomia del valore letterario dell’opera sia a prescindere dalla biografia e dalla personalità dell’autore;

Orlando, infatti, nel suo Ricordo di Lampedusa del 1963, riedito e seguito da Distanze diverse del 1996 (due elegantissimi volumetti, il primo della Scheiwiller, il secondo della Bollati Boringhieri [fig. 6], ha scritto: “Come ogni più o meno grande capolavoro, Il Gattopardo potrebbe essere letto senza sapere niente, perfino studiato senza sapere che un minimo essenziale dell’uomo Giuseppe Tomasi di Lampedusa… Accaparrata da questioni ideologiche irrelate alla forma letteraria, da una sicilianità che è nel tema e non nella ascendenze narrative, dal “caso” postumo del principe dilettante – datato ormai da quasi quarant’anni.” (Orlando, 1996, p. 86); una teoria, questa dell’Orlando, in netto contrasto con quella del Lampedusa, che si sentiva seguace di Sainte-Beuve (1804-1869), ovvero “indagare quanto le opere di letteratura siano condizionate, oltre che dalla società, dalla persona privata del loro autore” (Orlando, 1996, p. 84); le conclusioni dell’illustre studioso, alla fine delle sue minuziose indagini, sono che Il Gattopardo è “il solo romanzo mai scritto all’interno della stessa classe degli eredi, è lo spegnersi d’una lunga tradizione e perciò simbolicamente della stessa memoria, in una intimità che senza averne più coscienza subisca la storia giorno per giorno”. (Orlando, op. cit., 1998, p. 176); del resto, lo stesso Lampedusa aveva affermato che: “Il Gattopardo è l’aristocrazia vista dal di dentro senza compiacimenti ma anche senza le intenzioni libellistiche di De Roberto” (in Orlando, op. cit., 1998, p. 18).
Ma a parte queste analisi critiche, la piena comprensione della personalità di Giuseppe Tomasi di Lampedusa la si dovrebbe ricondurre, a mio avviso, agli anni 1953-1955-1957, forse quelli relativamente felici dello scrittore, prima, e poi, durante la stesura definitiva del Gattopardo (1955-57), ovvero al tempo in cui teneva le sue “lezioni” al giovanissimo Francesco Orlando, e talvolta anche ad altri pochi giovani, tra cui il futuro figlio adottivo Gioacchino Lanza di Assaro. È quindi in quel torno di tempo che il Tomasi ha vissuto il periodo più creativo e fecondo della sua vita, nelle stanze di Palazzo Butera alla marina, già appartenuto e alienato dai suoi antenati (e poi da lui ricomprato dopo la distruzione drammatica del Palazzo Lampedusa nel 1943, nella vecchia Palermo [fig. 7]), e nei diversi caffè nella città siciliana dove incontrava vecchi e giovani amici, il caffè-pasticceria del Teatro Massimo, Caflisch e Mazzara, ma soprattutto in quest’ultimo leggeva e scriveva, come ricorda Orlando: “Da Mazzara sarebbe poi scritta, letta e corretta buona parte del Gattopardo” (1963, p. 11).

***
La vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, come dicevo, è stata molto drammatica, basti leggere le Premesse critiche e biografiche ai vari capitoli che il figlio adottivo Gioacchino Lanza Tomasi ha pubblicato nel volume dell’Opera omnia, per renderci conto che quest’uomo mite e riservatissimo, chiuso nelle sue sterminate scritture sin da ragazzo, abbia vissuto da adulto tra due donne di fortissima personalità, sempre in conflitto tra loro: scrive il Lanza: “L’attaccamento della madre verso il figlio era superiore alla norma e fu causa di non pochi conflitti tra loro” (op. cit. p. XXI): la madre era Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò (1870-1946), persona molto incline a sollecitare gli interessi culturali e i viaggi all’estero del figlio, e la moglie, la baronessa baltica Alexandra von Wolff-Stomersee, più sopra citata, donna anch’essa coltissima e affermata psicanalista nella prima metà del Novecento, che il principe aveva sposato a Riga nel 1932 in una chiesa ortodossa. Poi i due coniugi si stabilirono a Palermo nel Palazzo Lampedusa. Ma durò poco. L’anno successivo la moglie ritornerà nel suo castello di Stomersee per l’assoluta incompatibilità con la madre del Tomasi. Il matrimonio comunque durò sempre e il principe alternava i suoi soggiorni tra Palermo e la Lettonia [fig. 8], e poi a Roma, dopo l’invasione tedesca della Polonia nel 1939, la Wolff-Stomersee si era trasferita in casa di sua madre, la nota cantante lirica italiana Alice Barbi (1858-1948), dove continuò ad esercitare la sua professione di psicoanalista. La coppia dei principi si stabilirà definitivamente a Palermo nel Palazzo Butera nel 1946, solo dopo la morte di Beatrice, madre del Lampedusa.

Il giovane Tomasi, come dicevo, ha viaggiato a lungo in Europa, e quasi sempre con la possessiva madre; vi è però qualche importante eccezione, quando il principe arrivò per la prima volta a Londra nel 1925, all’età di 28 anni da solo, per stare insieme allo zio Pietro Tomasi, marchese di Torretta, ambasciatore a Grosvenor Street.
Qui il futuro autore del Gattopardo poté godere di una libertà assoluta, come si legge in un lontano articolo, Quando il Gattopardo sbarcò nella città di Dickens, del noto scrittore e biografo delle regine inglesi, Richard Newbury, (Corriere della Sera, 8 aprile 2004), che ha scritto tra l’altro: “Se la sera il duca di Palma [tale era il titolo di cortesia del Tomasi, ancora vivente il principe suo padre, n.d.a.] – o Parma, come erroneamente lo ritenevano gli inglesi – doveva presenziare ai ricevimenti diplomatici, durante il giorno Londra diventò l’unica città dove egli potesse provare la soddisfazione di «scomparire» perdersi in un oceano, di non essere nessuno. Una delle prime passeggiate in quel mondo dei vari Dickens, dottor Johnson e Shakespeare, nel quale si era già immerso, mentre era ancora in Sicilia, fu la strada che conduceva fino a Whitechapel nei docks dell’East End, in compagnia della futura moglie… Licy, la figliastra di suo zio, di origine estone. Ci furono pellegrinaggi letterari ad Hampstead, la casa del suo poeta preferito, l’ «arcangelo» John Keats, alla Stratford di Shakespeare, verso Newstead Abbey, il casale gotico di Byron, a Oxford e Cambridge, e nel Lake District caro a Wordsworth”. Già Orlando aveva scritto, nel suo Ricordo di Lampedusa, la sensazione di libertà provata nella capitale inglese dallo scrittore siciliano: “Londra – mi disse press’a poco una volta – è la sola città che sappia dare in pieno la volontà di scomparire, di perdersi in un oceano, di non essere più nessuno” (1963, p. 36). D’altronde il Tomasi non faceva mistero della sua esterofila contro il provincialismo e la vana presunzione dei siciliani durante le sue “lezioni”, come ha scritto il figlio adottivo Gioacchino Lanza: “… l’Inghilterra doveva rimanere il modello di vita civile che preferiva e che più tardi cercherà di esaltare agli occhi dei suoi giovani allievi ed amici”(op. cit. p. XXVIII). Non si creda però che le lezioni lampedusiane siano state impartite con piglio accademico (cosa alla quale non aveva mai aspirato, lui, eruditissimo, stava solo maturando e sperimentando le sue qualità di futuro scrittore, proprio durante quelle lezioni), ma le condiva anche con umorismo, talvolta anche sarcastico, del tipo: “chi non è capace di ridere di un limerick, in fondo non capirà mai nulla dell’Inghilterra e della sua letteratura” (in: David Gilmour, L’ultimo Gattopardo. Vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Milano 1989, p. 68); il biografo, tra l’altro, scrive: “ Lontano dall’Italia era anche più felice. Suo cugino Lucio Piccolo [fig. 9], che una volta fece il viaggio insieme a lui, ricordava il cambiamento di Giuseppe dopo che ebbe passata la frontiera” (p. 64); (cfr. anche il capitolo I viaggi in Inghilterra, pp. 60-70; e Viaggio in Europa. Epistolario 1925-1930, di G. Lanza Tomasi e S. S. Nigro, Milano 2006).

E persino il giovane Orlando, nel suo Ricordo di Lampedusa, più volte rievoca il singolare aspetto didattico del suo maestro: “Ma nelle pagine che scriveva c’era ben poco di manualistico… le digressioni fiorivano ad ogni passo, spesso deliziose o divertenti, non risparmiando burle a spese dei presenti e dei loro gusti o lacune.” (1963, p. 25). Insomma le sue singolari Lezioni di Letteratura Inglese, pubblicate per la prima volta nel 1990 dalla Mondadori in due volumi, il primo dalle Origini al Settecento, il secondo dall’Ottocento al Novecento, con Introduzione di Gioacchino Lanza Tomasi, che non a caso le ha dedicate a Francesco Orlando, il destinatario appunto di codeste lezioni; lezioni che il Lampedusa ha scritto anche divertendosi, forse in omaggio alla massima latina dell’umanista Marsilio Ficino: Iocari serio et studiosissime ludere, durante gli ultimi quattro anni della sua vita, tra 1953 e il 1957, forse relativamente felici, e fuori dalla sua abituale solitudine.
***
Negli stessi anni, e più precisamente tra il 1955-1957, il principe ha scritto, prima del Gattopardo, quattro Racconti: Il mattino di un mezzadro o i Gattini ciechi, La gioia e la legge, I luoghi della mia prima infanzia, e Lighea o La Sirena (tra il 1956-57); quest’ultimo non piacque ad Orlando; nel frattempo per il giovane allievo l’apprendistato letterario presso il Lampedusa si era concluso, e si era allontanato dal maestro per portare a termine i suoi studi in Giurisprudenza; in seguito, quando ebbe a rincontrare lo scrittore, questi desiderò leggergli il suo ultimo lavoro. Ma l’allievo ascoltò il racconto con distrazione, arrivando a scrivere nel Ricordo: “La novella non mi piacque quanto il Il Gattopardo e glielo lasciai capire, benché fosse evidente la sua predilezione per quest’ultima creatura” (1963, p. 91); e Gioacchino Lanza, nella sua Introduzione alle Opere, ci ricorda, a proposito del compiacimento del Tomasi per questo testo, che: “Scrisse ancora due racconti, uno breve, La gioia e la legge, sul finire del ’56, l’altro ampio ed a cui teneva molto, La Sirena, nell’inverno del ’57” (op. cit. p. LIV). La Sirena, infatti, era il titolo dato dallo scrittore, mentre Lighea fu intitolato dalla vedova, la principessa Alexandra, per l’edizione Feltrinelli del 1961 (cfr. Lanza. op. cit. pp. 416-418). Si tratta quindi di una indimenticabile e affascinante narrazione, per i dialoghi tra il giovane Paolo Corbera e l’anziano e scorbutico professore e senatore catanese Rosario La Ciura, in ambientazioni rese con rara efficacia, sia della Torino verso la fine degli anni Trenta con i suoi tetri caffè, e poi sulla scintillante, remota riva jonica di punta Izzo ad Augusta, dove il bizzarro personaggio narra al Corbera l’incontro favoloso con una Sirena.

Ne I luoghi della prima infanzia (cito dall’edizione dei Racconti del 1961), invece, troviamo autentiche felicissime memorie dello scrittore (quest’ultimo racconto contiene infatti in nuce, tutti i germi del suo capolavoro, Il Gattopardo); qui Giuseppe Tomasi rivela a se stesso di essere un grande, ma sfortunato scrittore: difatti il romanzo, come è noto, fu rifiutato, mentre egli era ancora vivente, prima dalla Mondadori e poi da Elio Vittorini che definì l’opera un romanzo “attardato”, e perciò inidoneo ad essere inserito nella collana “I Gettoni” della Einaudi.
Il romanzo fu segnalato poi ad Elena Croce; fiducioso il Tomasi disse ad Orlando nell’estate del 1957: ”Per ora è nelle mani della figlia di Benedetto Croce!” (1963, p. 88), la quale lo trasmise a Giorgio Bassani, che senza esitazione, lo pubblicherà per Feltrinelli nel novembre del 1958; Il Gattopardo venne inserito nella storica collana “I Contemporanei”; nella stessa collana, tre anni dopo, apparvero, nel 1961, anche I Racconti [fig. 10].
Come si è detto più volte nel corso di questa nota, la vita del principe di Lampedusa è stata sempre molto drammatica (se si eccettua il tempo felicissimo della sua infanzia narrata nei Racconti); egli ha vissuto da militare la prima e la seconda guerra mondiale, e durante quest’ultima, ha visto la distruzione della molto amata casa, l’avito Palazzo Lampedusa nella vecchia Palermo, provocato da un bombardamento americano il 5 aprile 1943; “La amavo con abbandono assoluto, e la amo adesso quando essa, da 12 anni non è più – scrive il principe con queste struggenti parole nei suoi ricordi: “Tutte le altre case sono state per me dei tetti… ma non delle case nel senso arcaico e venerabile della parola” (p. 105). E ancora il Tomasi vuole riportare il tragico evento persino nel Gattopardo, nel capitolo sul “Ballo”, parte sesta del romanzo, laddove accenna agli affreschi del soffitto del Palazzo Ponteleone, rappresentanti gli dei; e con l’espediente letterario “prolessico”, di cui s’è detto, ha scritto: “Nel soffitto gli Dei, reclini su scanni dorati, guardavano in giù sorridenti e inesorabili come il cielo d’estate. Si credevano eterni: una bomba fabbricata a Pittsburg, Penn, doveva nel 1943 provar loro il contrario.” (in Il Gattopardo, 1960, p. 264)

Alcuni riferimenti iconografici nell’opera del Lampedusa
Nella rivista “Arabeschi”, n. 2, del luglio-dicembre 2015, è apparso l’interessante saggio di Marina Paino, La narrazione per immagini nelle pagine del Gattopardo, uno studio dal quale emerge la cultura figurativa di Giuseppe Tomasi e quella iconografica del film di Visconti. Lo scrittore, infatti, si diverte a beffeggiare l’arrogante e rozzo Sédara, quando questi sostiene che Angelica, la bella e colta figliola, “deve essere alloggiata bene”, e con la ricca dote “si possono rifare tutte le scale del Marruggia e tutti i soffitti del Sorcionario che esistono al mondo”. Il principe di Salina si guarda bene dal correggere l’ignorante interlocutore, in base anche al principio lampedusiano “Bisogna lasciare sempre gli altri nei loro errori”. Gli artisti erroneamente citati dal Sédara sono rispettivamente Giuseppe Venanzio Marvuglia [fig. 11], noto architetto siciliano tra Settecento e Ottocento (Palermo 1729-1814), autore, tra l’altro, della famosa Casina Cinese [fig. 12] a Palermo, commissionatagli da Ferdinando IV; l’altro artista è il pittore siciliano Gaspare Serenario (Palermo 1707-1759), autore di molti affreschi nella città palermitana, ma soprattutto ben noto a Lampedusa per i suoi dipinti nella chiesa barocca Maria Santissima del Rosario a Palma di Montechiaro [fig. 13], il paese fondato proprio dagli antenati del Tomasi, con il monastero [fig. 14] che fu già il palazzo dei Lampedusa; nel Gattopardo esso figura nel capitolo del viaggio a Donnafugata per la visita del principe al monastero per pregare sulla tomba della sua antenata la Beata Corbera.


Ancora riferimenti ad opere d’arte ben note a Firenze, dove Angelica aveva studiato, quando Tancredi e la ragazza sorprendono don Fabrizio, isolatosi dalla sala da ballo a Palazzo Ponteleone, fermo ad osservare da vicino una copia del noto dipinto La morte del giusto, 1778, di Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) (Louvre), come si vede nel fotogramma del film di Visconti; [figg. 15,16]; Angelica non comprese la frase di Tancredi rivolta allo zio: “Ma cosa stai guardando, corteggi la morte? […] I due giovani guardavano il quadro con noncuranza assoluta […]. Al momento di uscire Angelica sfiorò con le dita la tappezzeria di una poltrona, «Sono carine queste; un bel colore; ma quelle di casa sua Principe…»” (pp. 268-270). La ragazza esibiva il suo gusto, e aveva già dato prova della sua buona cultura, come si legge in un passo “analessico” nel capitolo sopra citato: “Le lunghe visite a Palazzo Donnafugata avevano insegnato molto ad Angelica”, che evidentemente conosceva le pitture di Palazzo Pitti, “lodò una Madonna del Dolci, [si tratta del dipinto di Carlo Dolci, detto Madonna delle Stoffe, 1630-35, fig. 17] ma fece ricordare che quella del Granduca [fig. 18] [di Raffaello, n.d.a.], aveva una malinconia meglio espressa” (p. 259).
Non poteva mancare infine il riferimento all’immagine della Madonna della lettera, nel capitolo finale del Gattopardo, sulla ispezione di un ecclesiastico, accompagnato dalle figlie di Don Fabrizio, Concetta, Carolina e Caterina, delle reliquie conservate nella cappella dei Salina, “Quando Monsignore entrò […] al di sopra dell’altare il quadro veneratissimo delle Signorine si trovava in piena luce: era un dipinto nello stile del Cremona e rappresentava una giovinetta […] nella destra essa stringeva una lettera spiegazzata; […] Monsignore si avvicinò […] rimase a guardare il quadro […] come se fosse stato un critico d’arte […]. «Una bella pittura» disse, «molto espressiva». «Un’immagine miracolosa, Monsignore, miracolosissima!, spiegò Caterina la povera inferma […]. Rappresenta la Madonna della Lettera»” [fig. 19] (1960, p. 307). Si tratta della protettrice dei messinesi e dal 1934 una gigantesca scultura posta su un’alta colonna all’ingresso del porto di Messina [fig. 20], sul modello di quella realizzata dell’artista Lio Gangeri (1845-1913), conservata nella Cattedrale della Città [fig. 21].
Un altro studioso del Gattopardo, Salvatore Silvano Nigro, ha poi suggerito alcuni anni fa un’altra interessante ipotesi iconografica, secondo la quale Tomasi di Lampedusa avrebbe preso spunto per il suo romanzo da un affresco del pittore Giuseppe Velasco (1750-1827) nel Palazzo dei Normanni a Palermo [fig. 22].


Ipotesi effettivamente da condividere poiché tale affresco rappresenta una transvolante apoteosi di Ercole [fig. 23]. Ha scritto Nigro: “Quello del principe di Salina è, nel Gattopardo, un portrait historié, nel quale il personaggio è trasfigurato e visto allegoricamente nelle spoglie di un Ercole Farnese”.
Va ricordato, a questo punto, la visita di Padre Pirrone, mentre il principe emerge dalla stanza da bagno, che: “…entrò proprio nel momento in cui egli, non più velato dall’acqua saponacea, non ancora rivestito dal provvisorio sudario, si ergeva interamente nudo, come l’Ercole Farnese, e per di più fumante” (1960, p. 85). Però Salvatore Silvano Nigro, nel suo puntuale articolo, ci fa notare opportunamente che l’Ercole-Salina non ascenderà all’Olimpo, salvato dal fuoco dal padre Zeus, ma “muore disilluso, vinto dal «fuoco» di Garibaldi-Vulcano, e senza la possibilità di rientrare nella propria reggia, nel proprio letto” (in Il volo del Gattopardo, “Il Sole 24 ore”, 9 marzo 2008).
* * *
“A sea change into something rich and strange. What potions have I drunk of Syren tears?*
(in Tomasi, Lighea, 1961, p. 74)
Vorrei aggiungere, infine, qualche personale osservazione su quello straordinario racconto del Tomasi, scritto negli stessi anni della stesura definitiva del Gattopardo: Lighea o La Sirena che ho già citato nel corso di questa nota. Esso è, a mio avviso, uno dei più bei racconti della letteratura italiana del Novecento, una storia di grande intensità poetica, persino superiore al Gattopardo; e segnalo in particolare le incantevoli pagine 82-94 della edizione del 1961, fantastiche ed evocative, che lo scrittore fa concludere in un’atmosfera fatata e tragica insieme. Eppure i Racconti non hanno goduto della stessa notorietà del Gattopardo. Il protagonista del racconto, l’anziano e scorbutico senatore siciliano, accademico “grecista”, nella Torino degli anni Trenta, stringe amicizia con il giovane Corbera (della famiglia gattopardesca) e gli narra la sua straordinaria storia d’amore giovanile con una sirena, durante una vacanza in un posto remotissimo sulle rive joniche di punta Izzo ad Augusta, nel caldo violento del mese di agosto. Allontanatosi in barca al sorgere del sole, riparandosi all’ombra di un roccione, il protagonista racconta: “Mi voltai e la vidi: il volto liscio di una sedicenne emergeva dal mare, due piccole mani stringevano il fasciame. […] Dai disordinati capelli color di sole l’acqua del mare colava sugli occhi verdi apertissimi, sui lineamenti d’infantile purezza […] mi portai all’altezza di lei, mi curvai, le tesi le mani per farla salire.[…] Era una Sirena” [si veda: fig. 24, G. A. Sartorio, La Sirena, 1893, Torino, GAM]. “Parlava greco e stentavo molto a capirla.” La sirena gli dice: “Ti sentivo parlare da solo in una lingua simile alla mia (il giovanissimo futuro professore stava declamando dei versi in greco); mi piaci, prendimi. Sono Lighea, son figlia di Calliope. Non credere alle favole inventate su di noi: non uccidiamo nessuno, amiamo soltanto”(pp. 83-85). Così alcuni giorni proseguono in maniera paradisiaca; “Mi narrava della sua esistenza sotto il mare, dei Tritoni barbuti, delle glauche spelonche…” (p. 89); “…passava ore distesa su uno scoglio a guadare l’orizzonte…, (p. 92), [si veda: fig. 25, F. Kupka, L’Onda, 1902, Ostrava, Gallery of Fine Arts].
Più volte, anche nel Gattopardo, e ne I luoghi della mia prima infanzia, il Tomasi descrive gli affreschi della casa Lampedusa a Palermo, e di quella di campagna, Filangieri di Cutò a Santa Margherita Belice, dai soffitti decorati con figure di Naiadi e Tritoni, secondo una iconografia, a mio parere, desunta dal ricordo di dipinti mitologici di Arnold Böcklin (1827-1901), [si veda: fig. 26, Il gioco delle Naiadi, 1886, Basilea, Kunstmuseum] (probabilmente visti dal principe durante i suoi viaggi europei in qualche soggiorno a Basilea o a Monaco), o verosimilmente da La Sirena, 1895 di Max Klinger a Firenze, Palazzo Pitti [fig. 27], o dalle primissime opere di Giorgio de Chirico, Tritone e Sirena del 1908-1909, Lugano, coll. priv. [fig. 28].
Ma a parte l’evocazione iconica, che qui segnalo per la prima volta, di questo splendido racconto, esso dovette essere stato ispirato anche dalla improvvisa scomparsa del giovane scienziato catanese Ettore Maiorana nel 1938. Difatti il figlio adottivo del Lampedusa, Gioacchino Lanza Tomasi, in un’intervista apparsa sul quotidiano “la Repubblica” del 12 ottobre 2014, ricorda che il Tomasi gli aveva confessato che la scomparsa del Maiorana lo aveva molto colpito. E non a caso, quindi, il racconto di cui sopra inizia con queste parole: “Nel tardo autunno di quell’anno 1938…”.
Non solo. Vi è un’altra coincidenza: tra le tante ipotesi sulla fine di Ettore Maiorana, (1906-1938) [fig. 29], vi è quella del suicidio dello scienziato scomparso in mare viaggiando su un piroscafo da Palermo a Napoli o viceversa. 
Nel racconto tomasiano, il protagonista de La Sirena, il grecista senatore La Ciura, era caduto (volontariamente?) in mare dal transatlantico Rex che navigava da Genova verso Napoli, memore delle parole della Sirena, che evidentemente non riusciva assolutamente a dimenticare: “Io ti ho amato e, ricordalo, quando sarai stanco, quando non ne potrai proprio più, non avrai che da sporgerti sul mare e chiamarmi…”(p. 89); il corpo di La Ciura non fu mai trovato,”…benchè delle scialuppe fossero state immediatamente messe in mare…”(p.92), come quello di Maiorana.
Nel racconto, simbolicamente, il protagonista viene rapito da quell’unico grande amore della sua vita. Di Maiorana, invece, rimane il mistero.
di Mario URSINO Roma Settembre 2017
*W. Shakespeare, La Tempesta, Atto I, scena 2















